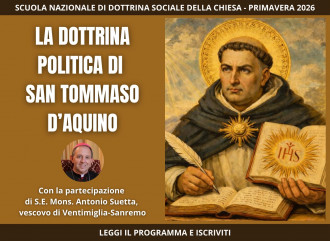Unioni civili e convivenze: l’involuzione di diritti e doveri
Ascolta la versione audio dell'articolo
Visite in ospedale, successione, alimenti, come per i coniugi: a fronte, però, di molti meno vincoli per i partner conviventi o uniti civilmente. Ecco perché la famiglia "allargata" a colpi di giurisprudenza finisce per sfaldarsi.

Accanto alla famiglia fondata sul matrimonio espressamente disciplinata dalla Costituzione (art. 29) e dal Codice civile (artt. 79 e ss.), le convivenze di fatto, siano esse eterosessuali o omosessuali, troverebbero tutela costituzionale nell’art. 2 della stessa Carta Costituzionale, ove si prevede che «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità…». La riconducibilità delle convivenze more uxorio nell’alveo dell’art. 2 Cost. è opera dell’attività interpretativa della giurisprudenza della Corte costituzionale a partire dagli anni ’80 (Corte cost. sentenza n. 237/1986), al fine di dare copertura costituzionale alle istanze tese a chiedere l’estensione di diritti riservati ai coniugi anche ai conviventi di fatto, sebbene – è stato evidenziato – tale riconoscimento costituzionale costituisca una “forzatura”, in quanto nelle intenzioni originarie dei padri costituenti non vi era la volontà di includere nella nozione di «formazioni sociali» ex art. 2 Cost. le relazioni di coppia diverse dalla famiglia «naturale» fondata sul matrimonio (anche la questione delle unioni omosessuali rimase del tutto estranea al dibattito svoltosi in Assemblea costituente).
Con l’intento di adeguare il concetto di famiglia alle trasformazioni sociali e culturali, e prima di ogni intervento legislativo in materia, la Corte Costituzionale affermò il principio dell’irriducibilità della “famiglia di fatto” alla famiglia fondata sul matrimonio, sia declinando alle convivenze more uxorio una (non possibile) applicazione analogica della disciplina prevista per la famiglia legittima (ex multis Corte cost. ordinanza n. 204/2003), sia escludendo il matrimonio alle coppie omosessuali ed indicando la via alternativa di una legislazione che individuasse le forme di riconoscimento di codeste unioni (Corte cost. sentenza n.138/2010).
L’invito della Corte costituzionale è stato accolto dal legislatore italiano con l’approvazione della Legge n. 76 del 20 maggio 2016 (c.d. Legge Cirinnà) che istituisce, regolandole, le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto (in linea con la maggioranza dei paesi occidentali). L’unione civile (art.1, commi 1-34) qualifica quella specifica formazione sociale ritualmente costituita «mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni» da due persone maggiorenni dello stesso sesso. La convivenza (art.1, commi 36-65) definisce quella relazione di fatto «tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile». La Legge 76/2016 estende ai conviventi una serie di diritti spettanti ai coniugi, che la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione aveva già riconosciuto a loro favore prima dell’intervento legislativo: si pensi, tra gli altri, al reciproco diritto di visita, assistenza e rappresentanza in caso di malattia o di ricovero; al diritto di successione nel contratto di locazione; al diritto del convivente in stato di bisogno di ricevere gli alimenti in caso di cessazione della convivenza. La Legge 76/2016 prevede poi che i conviventi di fatto possano disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza (art.1, comma 50 e ss.).
Ma ciò che più colpisce è la differente disciplina che caratterizza i diritti e doveri fra partner nelle unioni civili e nelle convivenze rispetto alle persone unite in matrimonio. In primis manca nella Legge 76/2016 – essendo le persone dello stesso sesso prive della naturale potenzialità procreatrice della coppia formata da un uomo e una donna – la disciplina sui doveri dei genitori verso i figli che caratterizza il matrimonio civile: «Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli…» (art. 147 c.c.). L’adozione di minori da parte di coppie omosessuali non è esplicitamente riconosciuta dalla legge, sebbene alcune pronunce dell’autorità giudiziaria abbiano riconosciuto la possibilità della cosiddetta stepchild adoption, che consente a una persona di adottare il figlio biologico del proprio partner.
In secondo luogo manca per le unioni civili l’istituto della separazione, quale fase preliminare ed “intermedia” prevista per i coniugi per poter accedere al divorzio e ottenere lo scioglimento del matrimonio. Le persone dello stesso sesso unite civilmente hanno il diritto di sciogliere direttamente il vincolo manifestando «anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile» (art. 1 comma 24 L.76/2016). Tra conviventi, il carattere di “unione libera”, basata sull’affectio quotidiana, fa sì che in ogni momento la coppia possa interrompere il rapporto.
In terzo luogo manca, sia per le unioni civili fra persone dello stesso sesso sia per le convivenze di fatto, la previsione dell’obbligo di fedeltà previsto, per i coniugi, dall’art. 143 c.c.: «Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione». Mentre l’art. 1 comma 11 della Legge 76/2016 prevede che «dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione», senza riferimento alcuno all’obbligo di fedeltà. Il dovere di fedeltà è omesso altresì nella disciplina delle convivenze di fatto, ove si cita la sola «reciproca assistenza morale e materiale» (art.1, comma 36).
In definitiva, si può affermare che la disciplina legislativa introdotta per le unioni civili fra persone dello stesso sesso e per le convivenze more uxorio ha determinato una trasformazione in senso negativo, una sorta di involuzione dei diritti e doveri che caratterizzano da sempre la famiglia fondata sul matrimonio. La procreazione e il ruolo genitoriale assumono una funzione non determinante nella qualificazione dei rapporti familiari. Il crescente diffondersi delle tecniche di procreazione medicalmente assistita e alcune aperture giurisprudenziali verso l’adozione di figli minori alle coppie omosessuali (seppur in casi particolari) conducono, anzi, alla dissoluzione del modello naturale di famiglia costituito da un padre e una madre e dei figli generati secondo l’ordine della sessualità umana.
L’unità della coppia è priva di ogni forma di tutela: lo scioglimento del rapporto di convivenza o di unione civile è rimesso alla sola volontà dei partner, in assenza di qualsivoglia presupposto o condizione. Del resto, se la ratio della convivenza di fatto risiede nell’esigenza di definirsi coppia “libera” nella quale si condividono esigenze ed affetti, finché dura la comunanza di interessi e senza alcun legame “costrittivo” che responsabilizzi la coppia, a questo criterio di definire e intendere la relazione familiare non si discosta molto la coppia omosessuale unita civilmente.
Scompare l’obbligo giuridico (ed etico) della fedeltà. L’esclusività del vincolo non è più considerata elemento fondante e caratterizzante le moderne formazioni familiari: coppie conviventi, siano esse eterosessuali o omosessuali (quest’ultimi anche se uniti civilmente) possono intrattenere relazioni affettive con partners estranei alla coppia, senza che ciò costituisca un problema, né per il diritto né per la morale. Difatti le convivenze more uxorio e le unioni civili fra persone dello stesso sesso fondano il proprio legame affettivo su quell’amore libero, che potrebbe finire o dirigersi altrove in qualsiasi momento. Prevale l’instabilità e la precarietà dei rapporti.
Emerge un quadro di rapporti familiari che si discosta dalla famiglia fondata sul matrimonio civile, come regolato dalle leggi dell’ordinamento dello Stato e declinato come «società naturale» dall’art. 29 della Costituzione, e che devia ancor più da quel modello di “perfezione” di famiglia che è il matrimonio cristiano, dalla cui natura sacramentale discendono le proprietà essenziali che lo fondano e lo caratterizzano.