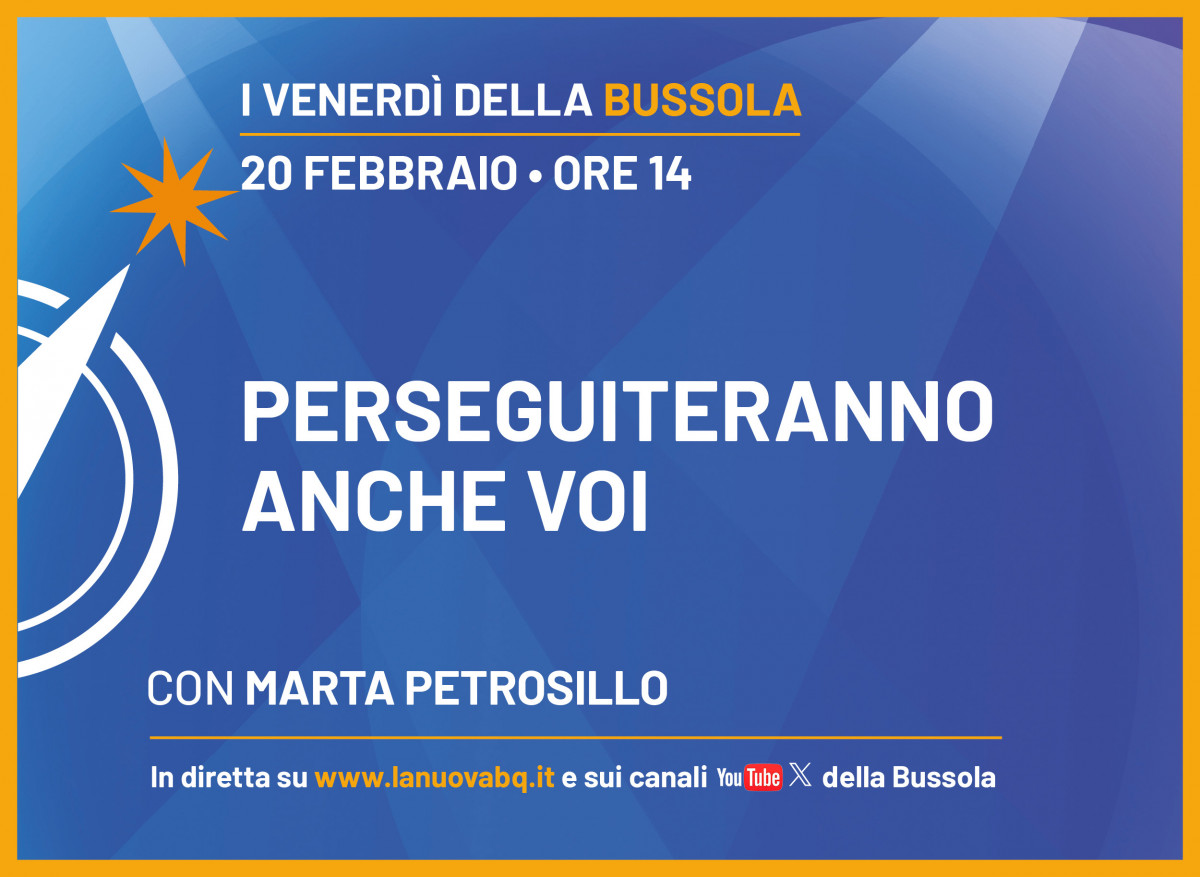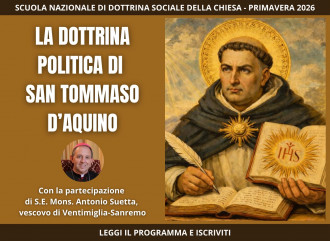Giuseppe Benedetto Cottolengo, il santo della Provvidenza
Ascolta la versione audio dell'articolo
Dopo una morte tragica che lo addolorò, il santo aprì a Torino il Deposito de’ poveri infermi del Corpus Domini. Fu questo il nucleo della futura Piccola Casa della Divina Provvidenza, capace di offrire accoglienza e speranza ai malati più bisognosi.

«La Provvidenza Divina pensa, dirige, provvede a tutto; io sono un semplice operaio», così scrisse san Giuseppe Benedetto Cottolengo (Bra, 3 maggio 1786 – Chieri, 30 aprile 1842) di cui oggi ricorre la memoria liturgica. Un operaio di Dio al servizio dei poveri. La sua figura si inserisce nel vasto panorama della Chiesa piemontese del XIX secolo e dei suoi “santi sociali”, come sono stati definiti. Attorno a lui, altri sacerdoti (tutti futuri santi) che hanno vissuto la loro vocazione come missione fra i poveri e soprattutto fra i ragazzi privi di educazione e dei primi bisogni per la loro vita. Sembra proprio che in quell’epoca, in quella determinata area geografica (il Piemonte), il Signore abbia voluto lasciare testimonianze mirabili della sua cura per i bisognosi. Basterebbe ricordare sacerdoti del calibro di san Leonardo Murialdo, san Giuseppe Cafasso e san Giovanni Bosco. Ed è bello osservare come la santità, la grazia, siano state in quel determinato periodo storico un fuoco propagatore: lo zelo per il Vangelo si è tramutato, incarnato, in un’eccezionale operosità.
Forse, appunto, il verbo “fare” è stato il verbo più importante nella biografia di san Giuseppe Benedetto Cottolengo. Un fare che corrisponde a un lasciarsi guidare dalla mano del Signore, ascoltando in piena umiltà la sua voce e affidando tutto alla Divina Provvidenza.
Nato il 3 maggio 1786 a Bra, una cittadina della provincia di Cuneo, in una famiglia medio-borghese, Cottolengo apprese i primi basilari principi cristiani nella sua casa d’origine: piccola casa con abbondanza di figli. Cottolengo fu, infatti, il primogenito di ben dodici figli: sei morirono in tenera età. La vocazione, giovanissimo: venne ordinato sacerdote l’8 giugno 1811 e, successivamente, divenne viceparroco a Corneliano d’Alba. Nel 1816, andò a Torino: qui, in questa città piena di contraddizioni sociali, si laureò in teologia alla Regia Università. Ed è proprio a Torino che gli fu affidato il primo importante incarico: venne nominato canonico della chiesa del Corpus Domini. La chiesa era nata per celebrare il miracolo eucaristico che avvenne nel 1453 durante la guerra tra il ducato di Savoia e il Delfinato, una delle antiche province francesi. In questo luogo, nel pieno centro della città piemontese, il giovane sacerdote poté venire in contatto con una Torino profondamente divisa: se da una parte cominciava la spinta borghese verso nuovi orizzonti economici e di progresso sociale, dall’altra parte vi era una fitta schiera di poveri, di persone che vivevano la loro esistenza in una povertà estrema. Diviene facile immaginare il Cottolengo percorrere le vie di Torino cercando di portare il Vangelo in tutte quelle famiglie disagiate. Un camminare per le strade che diviene metafora di un nuovo cammino interiore-spirituale: comprese, allora, sempre di più, che il Vangelo doveva divenire qualcosa di ancora più vivo e soprattutto da incarnare nella sua vocazione di sacerdote. Il Signore non tardò a rispondere al santo che si domandava come poter vivere pienamente il suo sacerdozio accanto agli ultimi.
C’è una data spartiacque nella biografia del Cottolengo: 2 settembre 1827. Il santo sacerdote venne chiamato al capezzale di una donna partoriente: non era riuscita a trovare rifugio in nessun ospedale di Torino. Riuscì a trovare, alla fine, un alloggio in un dormitorio pubblico, ma la sua situazione di salute stava degenerando sempre più. Fu allora che venne chiamato Cottolengo per assistere spiritualmente la giovane. Purtroppo la donna non riuscì a sopravvivere. Il sacerdote, lì, davanti a quella scena, rimase in silenzio, vivendo un profondo dolore: il suo animo era sconcertato davanti a una simile morte. Da questo episodio, domande e meditazioni, riflessioni sul suo fare, sul suo operato come ministro del Vangelo: rientrò, allora, nella chiesa del Corpus Domini. E fu nella preghiera che il Signore rispose alle sue domande. Decise di costituire nella chiesa una piccola infermeria.
Altra data fondamentale, quella del 17 gennaio 1828: il santo aprì a Torino, in una casa presa in affitto in via Palazzo di Città, quello che chiamò “Deposito de’ poveri infermi del Corpus Domini”, un luogo per accogliere la sofferenza e al contempo offrire speranza a molte persone che non riuscivano a trovare alloggio negli ospedali della città. Questo Deposito era il primo nucleo della “Piccola Casa della Divina Provvidenza” che cominciò il suo lavoro nel 1832: affittò un nuovo appartamento nel quartiere torinese Valdocco (quello di san Giovanni Bosco). Finalmente i poveri infermi avevano la loro casa. «Caritas Christi urget nos», questo il motto scelto dal santo. Le parole di san Paolo ai Corinzi furono il motore di questa impresa che il Cottolengo affidò completamente alla Provvidenza e non poteva che esserci, in fondo, motto più esaustivo di questo per spiegare il suo amore per il Signore e per i fratelli bisognosi. San Giovanni Paolo II, nella sua visita pastorale a Torino del 13 aprile 1980, riuscì a delineare un profilo del Cottolengo davvero completo: «Una caratteristica del santo è quella di non fare piani grandiosi ma di mettersi a disposizione della Divina Provvidenza come un umile “manovale”, un semplice strumento nelle mani di Dio Padre».
Il numero delle persone ospitate aumentò in poco tempo. Al Cottolengo serviva un aiuto: prima ci furono alcuni volontari che diedero una mano al sacerdote piemontese, poi, alcune donne che sotto la guida del santo formarono un nuovo istituto religioso.
Nel 1833 venne fondato anche il primo nucleo della comunità dei Fratelli Cottolenghini. Ultima famiglia religiosa, legata al nome del santo, quella dei sacerdoti (senza voti, con vita comune) istituita nel 1839. «Io sono un buono a nulla e non so neppure cosa mi faccio. La Divina Provvidenza però sa certamente ciò che vuole. A me tocca solo assecondarla», così amava ripetere il santo piemontese. La sua vita fu essenzialmente proprio questo: “assecondare” la Provvidenza, ascoltando soprattutto la Parola di Dio nella preghiera. E in umiltà.