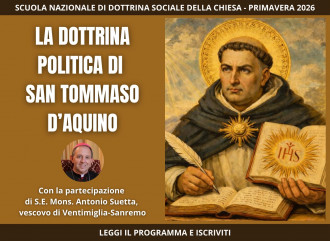Dal Madagascar al Camerun, l’Africa tra golpe e disordini
Ascolta la versione audio dell'articolo
Nel Paese dei malgasci, dopo il golpe bianco dell’esercito, il colonnello Randrianirina ha annunciato che prima del voto passeranno due anni. Morti e caos in Tanzania e Camerun, con elezioni prive di trasparenza. Tensioni anche in Guinea-Bissau.

Apparenze di sviluppo, simulacri di democrazia. Questa è la situazione, a mala pena dissimulata, di troppi stati africani.
In Madagascar l’esercito ha approfittato delle manifestazioni antigovernative della generazione Z e ha preso il potere con un golpe bianco, senza violenza né resistenza da parte delle istituzioni. Il presidente della repubblica, Andry Rajoelina, ha lasciato il paese il 12 ottobre, il giorno del colpo di stato, riuscendo a evitare di essere arrestato. I giovani nelle settimane precedenti avevano protestato per la carenza estrema di servizi, per la corruzione senza limiti, persino ostentata, per la totale mancanza di prospettive, visto il palpabile deterioramento delle condizioni di vita. Come tutte le capitali africane, Antananarivo è una città con grattacieli, ampie strade a diverse corsie, strutture ed edifici moderni costati milioni di dollari. Ma un terzo dei malgasci non ha luce elettrica e acqua corrente nelle case e anche quelli che ne dispongono lamentano sempre più frequenti interruzioni della loro erogazione. Il dato più sconcertante, incredibile se non fosse documentato, è che rispetto al 1960, anno dell’indipendenza dalla Francia, il reddito procapite dei malgasci è diminuito del 45%. Tre su quattro vivono sotto la soglia di povertà. Il colonnello Michael Randrianirina, il leder del reparto scelto che ha effettuato il golpe, ha assunto la carica di capo dello stato il 17 ottobre e ha annunciato che i militari governeranno per due anni e poi si andrà al voto. Se non manterranno l’impegno, dicono i leader della generazione Z, torneremo per strada, «vogliamo che cambi il sistema, non solo il leader».
Né il sistema né i leader sono cambiati nel frattempo in due paesi africani, la Tanzania e il Camerun, dove si è votato per eleggere capo di stato e parlamento in condizioni di totale mancanza di trasparenza.
La Tanzania è andata al voto il 29 ottobre. Quel giorno stesso sono iniziati i disordini, decine di migliaia di persone hanno invaso le strade delle principali città, urlando la loro frustrazione. Il motivo è che la presidente in carica, Samia Suluhu Hassan, per essere sicura di vincere ha di fatto impedito ai due più importanti partiti all’opposizione di partecipare al voto: il principale, Chadema, non è neanche stato ammesso e il suo leader, Tundu Lissu, è in carcere dallo scorso aprile con l’accusa di tradimento che gli può costare la pena capitale; l’altro partito, ACT-Wazalendo, si è visto squalificare il proprio leader candidato alla presidenza, Luhaga Mpina. Prima, per oltre un anno, Hassan aveva attuato una sistematica repressione del dissenso. Migliaia di esponenti e sostenitori dei partiti all’opposizione sono stati arrestati, uccisi, sequestrati, fatti sparire. I dimostranti hanno attaccato seggi e stazioni di polizia, dato fuoco a mezzi pubblici, tentato di raggiungere alcuni aeroporti costringendo alla cancellazione di diversi voli. La risposta delle forze dell’ordine è stata brutale. Hanno sparato ad altezza d’uomo. Secondo il Chadema, finora sono stati uccisi circa 700 civili, ma le proteste continuano. Altre fonti, tra cui una diplomatica, anonima, sostengono che ci sono prove attendibili che siano morte negli scontri almeno 500 persone. Come se niente fosse, sabato 1 novembre, la commissione elettorale ha annunciato che Hassan ha ottenuto una vittoria schiacciante: 97,66% dei voti.
In Camerun invece il presidente uscente, Paul Biya, si è accontentato di vincere con il 53% dei voti, ma anche così nessuno crede sia vero perché il risultato, diffuso dal Consiglio costituzionale il 27 ottobre, sovverte i risultati parziali di troppi seggi che invece davano la vittoria al principale sfidante, Issa Tchiroma Bakary. In Camerun si è votato il 12 ottobre. Fino all’ultimo si era sperato che il presidente Biya rinunciasse a candidarsi, lasciasse finalmente spazio a nuove leve. Ha 92 anni, governa da 43, questo sarebbe, o sarà, il suo ottavo mandato. Il paese ha disperato bisogno di qualcuno che sappia e voglia governare “cambiando sistema”, come anche lì chiede la generazione Z esasperata e stanca di corruzione, autoritarismo, incuria, palese disinteresse per il bene collettivo. La crescita economica, dopo un grave periodo di crisi tra il 1980 e il 2000, è discreta, ma non basta a contrastare disoccupazione e povertà: non si traduce come dovrebbe in sviluppo umano. Due fattori gravissimi di instabilità aumentano le preoccupazioni per il futuro del paese: la rivolta delle regioni anglofone (in Camerun il governo, le istituzioni e la maggioranza della popolazione parlano francese), in armi dal 2017; e, nell’estremo nord, le incursioni, gli attacchi dei jihadisti provenienti dalla vicina Nigeria. Anche in Camerun una parte della popolazione è insorta e il governo ha mandato l’esercito. I morti tra i civili si contano a decine.
Che ne sarà di Tanzania e Camerun è difficile prevederlo. Certo è che la fiducia della popolazione nelle istituzioni è stata ulteriormente compromessa. Hassan e Biya, se inizieranno il loro mandato, governeranno finché potranno contare sulla protezione dell’esercito. In Madagascar al presidente Rajoelina è venuta meno e può dirsi fortunato se ha potuto lasciare il paese.
Un altro stato africano sta per andare alle urne in un clima di estrema tensione, la Guinea-Bissau. Il mandato del presidente Umaro Sissoco Embaló è scaduto a fine febbraio di quest’anno, ma la Corte suprema ha accettato la sua richiesta di prolungarlo di sette mesi. Contro la decisione, l’opposizione aveva organizzato manifestazioni e uno sciopero nazionale. Il voto è previsto per il 23 novembre. In carica dal 2020, il presidente Embaló è riuscito a sventare due colpi di stato, l’ultimo nel 2023. Un terzo sembra sia stato neutralizzato nei giorni scorsi con l’arresto di diversi alti ufficiali dell’esercito.