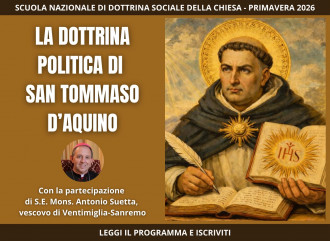Le tre attiviste e il volto violento del “femminismo predatorio”
Ascolta la versione audio dell'articolo
Denunciate per stalking, le attiviste femministe Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e Benedetta Sabene sono diventate un caso mediatico. Quando il Fatto Quotidiano ha esposto le loro chat, tutti hanno scoperto la loro violenza verbale.

Il caso delle tre attiviste Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e Benedetta Sabene rappresenta una delle vicende più controverse e divisive del femminismo italiano contemporaneo, una frattura che attraversa la sinistra e mette in discussione la credibilità stessa di una parte del movimento. Le tre donne, tutte note per la loro attività di divulgazione sui temi di genere e per l’impegno sui social nella lotta contro la violenza e la discriminazione, sono oggi al centro di un’indagine della procura di Monza per stalking e diffamazione, con accuse gravi che delineano un quadro di comportamenti persecutori e denigratori ai danni di un uomo, ex compagno di una di loro, e di altre figure pubbliche.
Secondo la ricostruzione della procura, la vicenda nasce da una denuncia presentata da un uomo che, dopo aver avuto una relazione con una delle tre, sarebbe stato oggetto di una campagna diffamatoria orchestrata da Vagnoli, Fonte e Sabene. I messaggi raccolti nel fascicolo raccontano di un vero e proprio accerchiamento digitale, una forma di persecuzione psicologica che avrebbe contribuito a spingerlo a un gesto estremo: il tentato suicidio. A questo primo filone si aggiunge poi una seconda denuncia, quella della social media strategist Serena Mazzini, accusata pubblicamente dalle stesse attiviste di far parte di un gruppo Telegram dedito a dossieraggi, bodyshaming e revenge porn, accuse rivelatesi infondate e configurabili anch’esse come diffamazione.
La procura ha recentemente chiuso l’inchiesta e ora spetterà al giudice per le indagini preliminari decidere se rinviare le tre a giudizio. Al di là dell’esito giudiziario, però, è già evidente che Vagnoli, Fonte e Sabene hanno oltrepassato il confine del confronto civile, rendendosi protagoniste di comportamenti che la stessa comunità femminista fatica a difendere. Le chat private, pubblicate da Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano, contengono frasi di una violenza verbale impressionante: insulti contro Michela Murgia, Liliana Segre, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e numerose altre figure pubbliche, spesso donne impegnate sul fronte dei diritti. Espressioni di disprezzo e aggressività che tradiscono un clima di odio interno, lontano da qualunque principio di emancipazione e rispetto.
Una spirale di rancore e violenza che ha messo in luce la degenerazione di certo attivismo radicale, dove la causa dei diritti si confonde con la volontà di sopraffazione. Persino voci storiche del femminismo hanno preso le distanze da questo modo di intendere la militanza. Tra le più dure, Anna Paola Concia, che in un’intervista al Corriere della Sera ha definito quello di Vagnoli, Fonte e Sabene un “femminismo predatorio”, una deriva che nulla ha a che vedere con la tradizione universalista della lotta per i diritti delle donne.
Concia ha accusato le tre di aver alimentato un clima d’odio e di aver goduto di un credito eccessivo da parte del mondo editoriale e culturale, che le avrebbe “coccolate”, garantendo loro visibilità e legittimazione. «Mi chiedo perché dare tanto spazio a persone che hanno costruito la propria notorietà sulla gogna e sull’aggressione verbale – ha dichiarato –. Ho provato a criticarle e sono stata a mia volta attaccata. Il loro pensiero è debole e il loro metodo sbagliato». Parole pesanti che segnano un solco netto tra due visioni opposte del femminismo: da una parte quella radicale incarnata dalle tre indagate, dall’altra quella universalista, che difende i diritti delle donne come valori da tutelare in ogni contesto, senza eccezioni ideologiche. Concia è arrivata a definire l’atteggiamento delle attiviste addirittura “maschilista”, sottolineando come la loro aggressività riproduca logiche di potere e sopraffazione.
In questo scenario, la sinistra si scopre divisa e incapace di una posizione unitaria. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, pur prendendo le distanze dai “metodi violenti”, non ha voluto condannare apertamente le tre attiviste, con le quali condivide una certa vicinanza culturale sul piano della battaglia per i diritti civili. Una scelta di silenzio che molti, tra cui la stessa Concia, hanno interpretato come una forma di ambiguità politica. «Mi aspetterei che la sinistra prendesse posizione – ha detto l’ex deputata – ma Schlein non lo fa perché è molto vicina a quel tipo di pensiero. Il risultato è che non si esprime». Le sue parole hanno aperto un dibattito aspro anche all’interno del mondo progressista, tra chi teme che la condanna delle tre possa trasformarsi in un attacco strumentale al femminismo e chi, al contrario, vede in questa vicenda il segno di una degenerazione ideologica che va fermata.
Intanto, mentre l’opinione pubblica discute, il caso giudiziario prosegue e i materiali diffusi dai media continuano a generare indignazione. Vagnoli si è difesa sostenendo che “il reato di antipatia non esiste” e accusando Lucarelli di aver orchestrato un processo mediatico per “punire i nemici”, ma le parole delle chat restano lì, difficili da giustificare, così come restano i reati ipotizzati che configurano una precisa responsabilità penale e morale. Dietro l’attivismo patinato emerge un volto oscuro del femminismo digitale: quello che si nutre di aggressività e che finisce per danneggiare proprio la causa che pretende di difendere. Molti, anche tra le stesse donne impegnate nella divulgazione, hanno espresso sconcerto: la giornalista Cecilia Sala ha commentato che «ci siamo fatti spiegare le molestie dagli indagati per stalking», mentre l’avvocata e attivista Cathy La Torre ha ricordato che «ciò che è scritto in quelle chat è reato, si chiama diffamazione, e chi non lo sa forse dovrebbe tacere». Persino chi ha voluto difendere le tre, denunciando l’uso improprio delle loro conversazioni private, non ha potuto negare che il contenuto dei messaggi rivela un problema etico profondo.
Alla fine, il caso Vagnoli-Fonte-Sabene è diventato il simbolo di una crisi più ampia, quella di un certo femminismo che si è trasformato in arena di potere, in cui la cancel culture è usata come arma e il linguaggio della lotta si confonde con quello dell’odio. Resta anche il nodo della facilità e della disinvoltura con la quale si spiattellano ai quattro venti le conversazioni private e le chat di persone indagate, il tutto amplificato da un circuito mediatico perverso e gravemente malato di sensazionalismo.