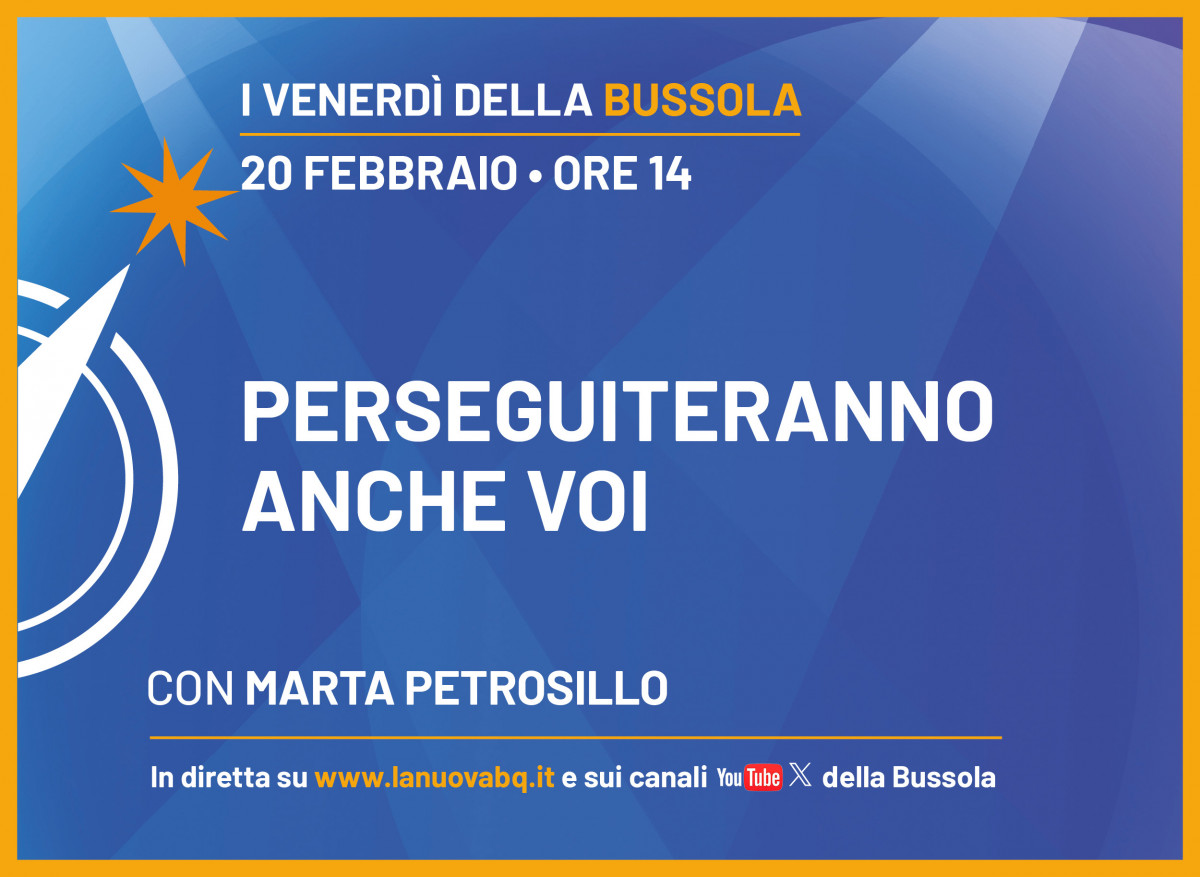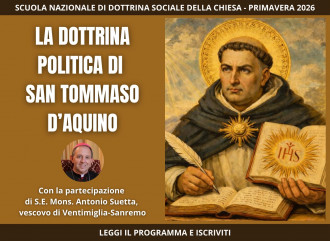La Regola di san Paolo della Croce, uno scrigno di sapienza
Ascolta la versione audio dell'articolo
Il 18 ottobre di 250 anni fa moriva a Roma il santo fondatore dei Passionisti, che 33 giorni prima aveva ricevuto l’approvazione dell’ultima versione della sua Regola. Un tesoro spirituale non solo per i membri della sua Congregazione, bensì per tutte le anime.

Cade oggi il 250° anniversario della morte di san Paolo della Croce, avvenuta a Roma il 18 ottobre 1775, all’età di oltre 81 anni e mezzo. Il fondatore dei Passionisti, al secolo Paolo Francesco Danei (1694-1775), tornò alla casa del Padre dopo una vita tutta spesa per la gloria di Dio e coronata, appena 33 giorni prima della morte, con la definitiva approvazione della Regola (15 settembre 1775) ad opera di Pio VI. La Regola (già approvata una prima volta nel 1741) era stata oggetto di opportune revisioni da parte dello stesso santo fondatore, revisioni che erano figlie della sua vita di preghiera e dell’esperienza che Paolo della Croce aveva maturato nei 34 anni alla guida della Congregazione dei Chierici scalzi della santissima Croce e Passione di Nostro Signor Gesù Cristo (questo il nome completo dell’istituto all’epoca). Il santo si preoccupò dunque di consegnare ai suoi confratelli, nel miglior modo possibile, la Congregazione che aveva fondato dietro precisa ispirazione divina. Mistico e pragmatico allo stesso tempo, dunque, come nella migliore tradizione della Chiesa.
Dio gli aveva ispirato anche l’abito e il simbolo dell’istituto. Erano passati alcuni anni da quella che Paolo chiamava la sua conversione alla penitenza (1713). Il santo era sulla strada verso casa, molto raccolto interiormente, dopo aver ricevuto la S. Comunione nella chiesa dei Cappuccini a Castellazzo Bormida (Alessandria). Fu allora, come scriveva nella prefazione al primo testo della Regola, che «fui elevato in Dio con altissimo raccoglimento, con scordamento di tutto e grandissima soavità interiore; ed in questo tempo mi vidi in spirito vestito di nero sino a terra, con una croce bianca in petto e sotto la croce avevo scritto il Nome SS.mo di Gesù in lettere bianche, ed in quest’istante mi sentii dire queste istesse parole: È questo in segno di quanto debba essere puro e candido quel cuore, che deve portare scolpito il Nome SS. di Gesù; ed io vedendo e sentendo ciò, mi posi a piangere, e poi cessò». Come il bianco, anche il nero ha il suo specifico motivo. Nella medesima prefazione (contenuta nella Lettera n. 325 ai Passionisti), Paolo spiegava ai confratelli che «il principal fine d’andar vestiti di nero (secondo la particolare ispirazione che Dio m’ha dato) s’è d’essere vestiti a lutto in memoria della Passione e Morte di Gesù, ed acciò non ci scordiamo mai d’averne una continua e dolorosa rimembranza».
Ma diamo uno sguardo alla Regola del 1775, che lo scorso 15 settembre, memoria dell’Addolorata, ha compiuto appunto 250 anni. Essa consta di 38 capi. Nel primo si spiega il fine della Congregazione: la maggior gloria di Dio, che a sua volta si collega al profitto spirituale che i membri dell’istituto devono conseguire e quindi alla salvezza delle anime. Perciò, i religiosi che saranno destinati alla predicazione «procureranno, sì nelle apostoliche missioni che in altri pii esercizi d’insegnare a viva voce ai popoli la devota memoria della Passione e Morte di Gesù Cristo Signore Nostro, da cui, come da fonte, deriva ogni bene».
Se questa è la missione propria dell’istituto fondato da san Paolo della Croce, si comprende che chiunque voglia esserne ammesso deve verificare bene la propria vocazione e avere il desiderio di conformarsi a Gesù. Il postulante, infatti, si legge nel capo IV, «considererà se per la gloria di Dio, e per la salute sua e dei prossimi, sia veramente disposto a patir molto, a essere burlato, disprezzato, e soffrire volentieri travagli e tribolazioni».
Com’è noto, oltre ai tre voti classici (castità, obbedienza, povertà), i Passionisti professano un quarto voto, che è proprio quello di promuovere la devozione alla Passione e Morte del Signore Gesù. Paolo della Croce, nel capo XVI, spiega che i confratelli assegnati alla predicazione devono insegnare, in modo breve e chiaro, «la maniera pratica di meditare (…) questi sacrosanti misteri», affinché questa stessa meditazione divenga «familiare e perseverante». L’insegnamento deve essere semplice per tutti, tanto più per gli ignoranti, ai quali il santo raccomanda di insegnare «brevi riflessioni» e giaculatorie, capaci di muovere il cuore all’amore di Dio.
La devozione alla Passione è autentica se cambia nel concreto le persone, cioè se si vive tutto in unione a Gesù crocifisso e risorto: «Si raccomandi loro – scrive Paolo – di offrire sempre ogni patimento in unione di quanto ha patito per noi il divin Redentore, e dimostrino quanto ciò importi, quanto sia vantaggioso e meritorio per conseguire gran premio», ossia la ricompensa eterna che spetta ai giusti.
La gratitudine per il Redentore va accompagnata a quella per sua Madre, la Corredentrice. E difatti il fondatore dei Passionisti, al capo XXI (Dell’orazione), raccomanda ai confratelli di prendere la Vergine Maria come «loro principale protettrice» ed esserle particolarmente devoti: «Si ricordino spesso degli acerbissimi dolori da lei sofferti nella passione e morte del Figlio, e con la voce e coll’esempio promuovano negli altri la divozione verso di questa nostra Signora».
Accanto all’orazione, al digiuno e agli altri mezzi per progredire nel cammino cristiano, san Paolo della Croce ricorda l’importanza della formazione. In ogni Provincia dell’istituto devono esserci una o due case per lo studio, dove «i giovani studino la filosofia e teologia, per rendersi così più abili alla coltura delle anime». Punto di riferimento delle scuole dei Passionisti deve essere quella che il fondatore chiama l’«inconcussa dottrina dell’angelico dottore S. Tommaso».
Particolari raccomandazioni sono dedicate nella Regola ai missionari. Non solo essi devono istruire i popoli a meditare i misteri della vita, passione e morte di Gesù, ma devono più in generale insegnare ai fedeli ad abituarsi alla preghiera, «confutando nel tempo medesimo il pernicioso errore di coloro, che credono essere la meditazione propria solamente delle persone ecclesiastiche e religiose». I missionari dovranno quindi ammaestrare i fedeli ad avere fiducia in Dio e spiegare che «nell’orazione Iddio comunicherà loro i suoi lumi, con i quali conosceranno sempre più gl’inganni del demonio e del mondo, la bruttezza del vizio, e la bellezza della virtù».