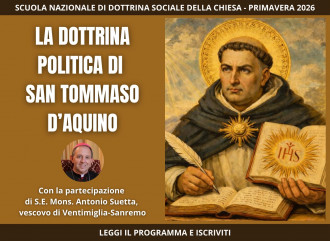Da dove arrivano i cardinali africani, terre di sangue e di martiri
Ascolta la versione audio dell'articolo
Nel prossimo Conclave, 18 sono africani e provengono quasi tutti da paesi difficili, nei quali l’attività pastorale e la testimonianza della Fede richiedono speciale dedizione e non di rado coraggio.

Il 7 maggio inizierà il Conclave. Vi parteciperanno 133 cardinali elettori. 18 sono africani e provengono quasi tutti da paesi difficili, nei quali l’attività pastorale e la testimonianza della Fede richiedono speciale dedizione e non di rado coraggio. Due in particolare convivono, al fianco dei loro fedeli, con la devastante minaccia del jihad, la guerra santa islamica. Sono Nakellentuba Philippe Ouédraogo, Arcivescovo Metropolita emerito di Ouagadougou, la capitale del Burkina Faso, e il nigeriano Peter Ebere Okpaleke, vescovo di Ekwulobia, città dello Stato sud orientale di Anambra.
Il Burkina Faso (64% della popolazione musulmana, 26% cristiana) è uno dei paesi dell’Africa sub sahariana in cui i terroristi islamici sono riusciti a insediarsi. A causa loro, i cristiani vivono in condizioni disperate. I frequenti attacchi alle chiese hanno indotto molti fedeli a smettere di recarvisi. Centinaia sono state chiuse. Nel 2024 per mano jihadista sono morti due catechisti: François Kabore, ucciso mentre guidava un incontro di preghiera, e Edouard Zoetyenga Tougbare catturato, torturato e ucciso. La giunta militare al potere – in Burkina Faso ci sono stati due colpi di stato nel 2022 – si sta dimostrando ancora meno efficace dei governi civili precedenti nel contrasto al jihad. La Nigeria (musulmani 53,5%, cristiani 45,5%) è il paese al mondo in cui ogni anno vengono uccisi più cristiani: 3.100 nel 2024. Dato come “tecnicamente sconfitto” nel 2016, invece il jihad oggi conta tre gruppi armati, Boko Haram, Iswap e Lakurawa. Inoltre i cristiani subiscono aggressioni e attacchi da parte dei Fulani, una etnia di fede islamica dedita alla pastorizia, sempre più frequenti e letali soprattutto negli stati centrali dove musulmani e cristiani convivono. L’Anambra è uno di questi. I religiosi nigeriani sono spesso vittime anche di sequestri a scopo di estorsione. Dall’inizio del 2025 ne sono stati rapiti già 11, incluse due suore catturate proprio nell’Anambra e in seguito rilasciate. Due religiosi, padre Sylvester Okechukwu e il seminarista maggiore Peter Andrew, sono stati uccisi.
Altri cardinali africani elettori presenti al Conclave condividono con i fedeli le difficoltà e i pericoli della guerra. Due, in particolare, provengono da due paesi visitati da papa Francesco e da lui molto amati. Sono Dieudonné Nzapalainga, arcivescovo metropolita di Bangui, la capitale della Repubblica Centrafricana, e Stephen Ameyu Martin Mulla, arcivescovo di Juba, la capitale del Sudan del Sud.
Nel 2015 papa Francesco aprì nella cattedrale di Notre-Dame di Bangui il Giubileo della Misericordia e proclamò la città “capitale spirituale del mondo”. Il paese era in guerra dal 2012, anno del colpo di stato messo a segno da una coalizione di movimenti antigovernativi. Lo scontro era tra musulmani e cristiani, feroce, contrassegnato da episodi di violenza inaudita. «Se apriamo la porta del nostro cuore alla misericordia, la pace arriverà anche qui», aveva esortato allora il cardinale Nzapalainga. Non fu ascoltato. Nonostante una serie di accordi di pace, tutti subito violati, il conflitto ancora continua. Decine di gruppi armati controllano e si contendono il 70% del territorio nazionale. I mercenari russi garantiscono la sicurezza nell’area della capitale in cambio del permesso di sfruttare i giacimenti di oro e diamanti del paese. Servizi e infrastrutture, trascurati anche prima della crisi del 2012, ormai sono in condizioni pessime. Monsignor Aurelio Gazzera, vescovo di Bangassou, racconta che per percorrere in auto i 750 chilometri che separano la sua diocesi dalla capitale impiega due settimane, questo durante la stagione secca quando le strade sono in condizioni migliori. Il rischio, sempre, è di incappare in gente armata e combattenti o di saltare su una mina.
Il cardinale Mulla sostiene che il tribalismo è il più grande nemico del suo paese. «Non possiamo costruire la nostra nazione o la Chiesa fondandole sul tribalismo» non si stanca di ammonire, e a ragione, perché la conflittualità tribale è stata ed è tuttora la rovina del Sudan del Sud: nei decenni in cui i suoi abitanti, cristiani e di origine africana, sono stati perseguitati dalle tribù musulmane di origine araba, quando ancora il territorio faceva parte del Sudan, e poi a partire dal 2013, due anni soltanto dopo l’indipendenza ottenuta nel 2011, quando le tribù maggiori, i Dinka e i Nuer, hanno scatenato una guerra per il controllo dell’apparato statale, tutta giocata sull’appartenenza tribale. Un accordo firmato nel 2018 non ha messo del tutto fine al conflitto, continuato a bassa intensità specie in alcune aree del paese. Proprio nei mesi scorsi le tensioni tra Dinka e Nuer si sono accentuate e si teme la ripresa della guerra civile su vasta scala.
Lo stesso cardinale Mulla ha sperimentato personalmente il ruolo deleterio del tribalismo. Nel 2019 la sua nomina ad arcivescovo di Giuba fece discutere e fu contestata dai Bari, il gruppo etnico maggioritario nella provincia in cui si trova la capitale, nel sud del paese, perché lui è un Otuho, una etnia radicata delle province settentrionali. Non era il primo caso del genere. In altre occasioni, in Sierra Leone ad esempio, nel 2012, fu il Vaticano a dover cedere e revocare la nomina di un vescovo “straniero”.