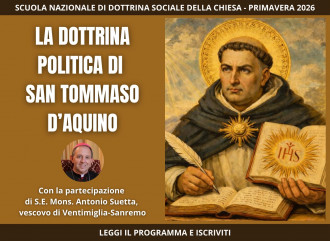Corsa al riarmo, costi che l'Europa non può permettersi
Ascolta la versione audio dell'articolo
Il massiccio riarmo dell’Europa appare politicamente inattuabile e finanziariamente insostenibile. All’Europa converrebbe trovare una soluzione negoziata al conflitto per avere condizioni favorevoli di approvvigionamento e costo dell’energia.

Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato ieri un regolamento che istituisce lo strumento Azione per la Sicurezza in Europa (SAFE), “nuovo strumento finanziario che sosterrà gli Stati membri che desiderano investire nella produzione industriale per la difesa attraverso appalti comuni, concentrandosi sulle capacità prioritarie".
SAFE finanzierà programmi urgenti e su larga scala nella base tecnologica e industriale di difesa europea con l'obiettivo di aumentare la capacità produttiva, garantire la disponibilità di equipaggiamenti di difesa quando necessario e colmare le lacune in termini di capacità esistenti.
SAFE consentirà all'Ue di sostenere ulteriormente l'Ucraina associando la sua industria della difesa allo strumento fin dall'inizio. Attraverso SAFE, l'Ue fornirà fino a 150 miliardi di euro che saranno erogati agli Stati membri interessati su richiesta e sulla base di piani nazionali. Le erogazioni assumeranno la forma di prestiti a lunga scadenza a tassi competitivi, che dovranno essere rimborsati dagli Stati membri beneficiari.
Al di là dell’indebitamento ulteriore dei singoli stati per le spese militari restano però molti dubbi circa la sostenibilità economica del riarmo europeo soprattutto alla luce dell’attuale contesto economico. Da tempo la UE tende ad attribuire alla diversificazione di programmi e stanziamenti dei singoli stati membri le difficoltà ad attuare un ampio programma di riarmo che persegua una progressiva integrazione militare dell’Europa che però non è prevista da nessun trattato.
I problemi strutturali che oggi rendono politicamente impossibile ed economicamente insostenibile il massiccio riarmo dell’Europa sono anche finanziari e industriali. Modificare l’impostazione delle industrie europee per la Difesa verso produzioni di massa è un processo che richiede forti investimenti, diversi anni, molte migliaia di nuovi lavoratori specializzati non reperibili oggi sul mercato e soprattutto un agevole e conveniente accesso a materie prime, acciaio, esplosivo e soprattutto energia a buon mercato.
Condizioni inesistenti oggi in Europa dove da quasi tre anni la rinuncia al gas russo a buon mercato ha determinato calo della produzione industriale, progressiva deindustrializzazione, incremento dei costi energetici, inefficienza ed elevati costi delle linee di approvvigionamento e difficoltà a reperire materie prime sempre più costose. Rispetto al 2021 il costo medio dei prodotti militari è triplicato: negli ultimi mesi del 2024 fonti industriali riferirono al web-magazine Analisi Difesa che tra il 2021 e il 2024 il prezzo medio dell’esplosivo a uso militare è lievitato del 90%, l’acciaio del 59%, l’alluminio del 50%, i circuiti stampati del 64% e la carpenteria leggera di oltre il 100%.
Un proiettile d’artiglieria da 155 mm prodotto in Europa costa tra i 2.500 e i 4.000 euro senza contare spolette e sistemi di guida. Se si considera che nel conflitto in Ucraina i russi arrivano sparare anche 15/18 mila proiettili al giorno e gli ucraini 5/6mila si comprende quale sforzo finanziario sia richiesto oggi per riempire i magazzini e sostenere la guerra dell’Ucraina.
Le bombe d’aereo prodotte in Europa sono passate, a seconda del peso e del tipo di esplosivo impiegato, da 6/30 mila euro nel 2021 a 12/60 mila nel 2024. E parliamo solo del “corpo bomba”, senza i sistemi di guida che le rendono precise.
Chiaro quindi che l’incremento delle spese militari gonfierà i bilanci della Difesa, i fatturati e ricavi delle aziende del settore ma non consentirà di acquistare maggiori quantità di sistemi d’arma o munizioni. Il caso della Gran Bretagna è emblematico: con una spesa militare incrementata fino a raggiungere il 2,3 per cento del PIL nel 2025 (+ 15 per cento rispetto al 2023), Londra ha dovuto radiare 50 aerei da combattimento, 30 elicotteri, 55 droni e 5 navi militari oltre a trovarsi con il livello minino di soldati dai tempi delle guerre napoleoniche e ad aver radiato tutti i semoventi d’artiglieria che verranno rimpiazzati solo dal 2030 da nuovi mezzi. Militarmente la Gran Bretagna, come tutte le nazioni d’Europa, è oggi molti più debole rispetto al 2021 pur spendendo molto di più di allora per la Difesa.
In Germania, dove il cancelliere Frederich Merz ha dichiarato di voler logorare la Russia per convincerla ad accettare un cessate il fuoco, il Centro Studi Bruegel e il Kiel Institute hanno messo a confronto i costi di alcuni mezzi terrestri occidentali con gli omologhi russi e cinesi. In tema di carri armati un Leopard 2 A8 tedesco costa oggi 29 milioni di euro contro i 17,5 di un M1A2 Abrams statunitense, i 9,2 di un più vecchio Leopard 2A6, i soli 4,1 milioni di un T90 russo e i 2,3 milioni del cinese Type 99A.
Considerato che la guerra in Ucraina ha confermato che non esistono armi risolutive o invincibili e che nessun carro armato è invulnerabile, con il costo di un singolo nuovissimo Leopard 2A8 si producono quasi 2 carri statunitensi Abrams (di cui l’US Army ha in riserva oltre 2mila esemplari), 7 T-90 russi e quasi 13 tank cinesi di ultimo modello.
Il confronto tra semoventi d’artiglieria non cambia i termini della questione: il cingolato tedesco Pzh 2000 costa 17 milioni di euro, circa il triplo dei ruotati Caesar francese e Zuzana slovacco (5,9 milioni) mentre il sudcoreano K9 Thunder, che tanto successo sta avendo in Europa costa 3 milioni e il russo 2S19 MSTA-S appena 1,4 milioni, meno dell’ucraino “2S2 Bohdana (2,3 milioni) che ha lo stesso prezzo del cinese Norinco PZL 05.
Per semplificare, con il costo di un semovente cingolato tedesco Pzh 2000 si comprano quasi 6 semoventi sudcoreani K9 e 12 MSTA russi. Questi ultimi costano molto meno anche dei semoventi ruotati europei quali il francese CAESAR (rapporto di quasi 1 a 4) e il tedesco RCH-155 (rapporto quasi 1 a 8). Il semovente russo costa ancor meno del vecchio M-109 Paladin, ormai datato e consegnato all’Ucraina da molti alleati occidentali (Italia inclusa) in diversi esemplari il cui prezzo è valutato 1,6 milioni mentre con i costi di un Pzh-2000 i russi realizzano 12 MSTA-S.
L’Osservatorio dei conti pubblici italiani ha recentemente rilevato che gli aerei da combattimento occidentali più avanzati hanno raggiunto nel 2024 un costo pari a 169 milioni di euro per un Eurofighter Typhoon, 152 milioni per un F-35 e 119 milioni per un Rafale. Difficile stabilire il prezzo di un Sukhoi Su-35 russo, che i cinesi pagarono 20 milioni di euro ad esemplare nel 2015 ma se oggi il suo costo fosse anche raddoppiato rappresenterebbe sempre un terzo o un quarto dei suoi concorrenti occidentali.
Come la Commissione Europea, anche gli analisti tedeschi attribuiscono il fenomeno alla frammentazione del mercato Ue, all’assenza di un mercato unico, alle commesse dei singoli stati e all’assenza di un sistema di acquisizioni comune a tutti gli stati membri.
«I governi europei ordinano quantità relativamente piccole di armi e munizioni. Di conseguenza, è difficile beneficiare delle economie di scala, che in linea di principio porterebbero a una produzione più rapida ed economica e a volumi di produzione più elevati. Ciò è dovuto anche a un mercato frammentato per i prodotti della difesa, in cui ogni paese dell’UE ordina separatamente» si legge nello studio di Bruegel.
A queste motivazioni occorre però aggiungere che, a differenza della Russia, che dispone di tutte le materie prime e di energia infinita a prezzo stracciato, l’Europa paga oggi l’assenza delle materie prime, il costo dell’energia più alto tra tutte le aree industrializzate del mondo al punto da aver costretto molte acciaierie a chiudere almeno parte degli stabilimenti mentre in Polonia la Huba Czestochowa è stata rilevata direttamente dal ministero della Difesa.
Vi è poi un’altra differenza non irrilevante tra il sistema produttivo russo e quello Occidentale che contribuisce a far lievitare i costi del riarmo europeo.
Dal 2022 tutte le aziende occidentali del settore Difesa, su entrambe le sponde dell’Atlantico, hanno visto gonfiarsi gli ordini, i ricavi e le quotazioni borsistiche con i relativi dividendi per gli azionisti, che in Europa sono spesso anche gli stessi stati. L’apparato industriale russo, incentrato sul colosso pubblico Rostec (800 tra aziende e centri di ricerca con oltre 600 mila dipendenti), ha tagliato le esportazioni per soddisfare le esigenze belliche nazionali riducendo drasticamente i profitti perché “la società ha preso più ordini dalla Difesa, con una redditività nulla o addirittura negativa”, ha sottolineato l’amministratore delegato di Rostec, Sergei Chemezov.
Potremmo quindi affermare che l’industria della Difesa russa lavora per la Patria mentre quella occidentale per i dividendi degli azionisti. Per tutte queste ragioni, il massiccio riarmo dell’Europa, nella misura in cui viene oggi da più parti evocato, appare politicamente inattuabile e finanziariamente insostenibile.
All’Europa converrebbe oggi trovare una soluzione negoziata al conflitto russo-ucraino per ritornare ad avere condizioni favorevoli di approvvigionamento e costo dell’energia oltre che di accesso alle materie prime per dare vita almeno a quei programmi di potenziamento militare considerati più urgenti.