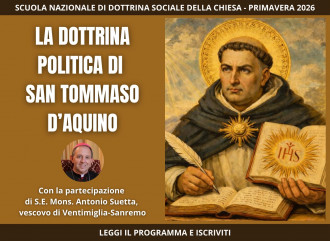Cambiamento climatico, i danni li fa il catastrofismo mediatico
Ascolta la versione audio dell'articolo
Dopo la fine della pandemia, il cambiamento climatico è diventato il principale motivo del catastrofismo mediatico. Approfittando del gran caldo estivo, iniziato a giugno, ogni giorno ci viene imposta la nostra dose di terrore.

Negli ultimi anni si è assistito a una crescente tendenza al sensazionalismo e al catastrofismo narrativo da parte dei media, con particolare riferimento alle notizie di carattere ambientale e climatico. Dopo la pandemia da Covid-19, che ha monopolizzato l’informazione e in molti casi ha esasperato l’allarmismo, oggi è il caldo estivo a essere diventato protagonista di un racconto mediatico che spesso assume toni drammatici e sproporzionati rispetto alla realtà.
Titoli allarmanti, immagini apocalittiche, toni da bollettino di guerra: il caldo viene narrato quasi come una nuova emergenza sanitaria globale, al pari del virus che pochi anni fa ha paralizzato il mondo. Il problema, però, è che molte morti vengono automaticamente associate alle alte temperature, senza un reale riscontro scientifico o senza attendere gli accertamenti medici. Si tratta di un processo fuorviante, che porta a interpretare ogni decesso sospetto come legato al caldo, quando spesso le cause sono ben diverse e legate a patologie pregresse, a condizioni di fragilità o a dinamiche del tutto indipendenti dal clima.
Questo approccio, oltre a confondere l’opinione pubblica, contribuisce ad alimentare un’ansia collettiva e una percezione distorta del rischio. Parallelamente, questa narrazione allarmistica si traduce anche in un’opportunità politica: l’Unione Europea e molte forze governative nazionali stanno cavalcando l’onda dell’emergenza climatica per giustificare un’accelerazione sulle politiche ambientali, proponendo misure radicali in nome dell’ecologismo. Sebbene la transizione ecologica sia un obiettivo condivisibile, il rischio concreto è che questa venga imposta secondo logiche ideologiche più che razionali, con effetti devastanti per interi settori produttivi, sull’occupazione e sull’economia in generale.
L’ideologia green, se applicata senza gradualità e pragmatismo, rischia di diventare una nuova forma di dogmatismo che penalizza la crescita e la competitività dei paesi europei. In questo contesto, il ruolo del giornalismo diventa cruciale. I media non possono e non devono essere strumenti di propaganda o amplificatori di paure irrazionali.
Già il Testo unico dei doveri del giornalista, approvato nel 2016 dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, sottolineava la necessità di una narrazione sobria e responsabile in caso di possibili allarmi per la salute pubblica. In particolare, durante la seconda ondata della pandemia da Covid-19, nel novembre 2020, lo stesso Consiglio nazionale approvò una modifica dell’articolo 6 del Testo unico, inserendo un riferimento esplicito all’informazione scientifica, con l’intento di garantire standard più elevati di verità e attendibilità. Il nuovo testo dell’articolo 6 recitava: “L’informazione su materie scientifiche e sanitarie, in particolare in caso di emergenze, deve essere diffusa con particolare senso di responsabilità. Il giornalista è tenuto a verificare con la massima scrupolosità le fonti scientifiche, evitando la diffusione di notizie che possano creare allarmi infondati. Il giornalista deve distinguere chiaramente i fatti dalle opinioni personali e dai pareri di esperti, indicando sempre le fonti e il grado di attendibilità degli studi citati. In ogni caso, il giornalista è tenuto a rispettare il principio di veridicità delle informazioni e a correggere tempestivamente eventuali errori, rettificando notizie rivelatesi false o non fondate”.
Un ulteriore passo avanti è stato compiuto con l’approvazione del nuovo codice deontologico dei giornalisti nel dicembre 2024, che ha sostituito il Testo unico ed è entrato in vigore il primo giugno. Questo codice, all’articolo 26, affronta direttamente il tema dell’informazione ambientale, scientifica e sanitaria, richiamando il dovere di evitare allarmismi e di attenersi a criteri rigorosi di attendibilità. Si legge nell’articolo 26: “Il giornalista: verifica l’attendibilità e l’autorevolezza delle fonti prima di diffondere notizie su temi ambientali, scientifici e sanitari, evitando di suscitare timori o speranze infondate e correggendo le notizie rivelatesi non veritiere.” Questo principio dovrebbe essere un faro per tutti coloro che operano nel mondo dell’informazione, soprattutto in un periodo storico in cui il clima è diventato un argomento mediaticamente molto sensibile e spesso strumentalizzato.
È indubbio che i cambiamenti climatici siano in atto e che vadano affrontati con serietà e visione, ma attribuire a questi ogni disastro, ogni tragedia o anomalia meteorologica è fuorviante e diseducativo. L’informazione deve essere lo strumento attraverso cui la cittadinanza viene messa in condizione di comprendere, riflettere e agire consapevolmente, non un mezzo per generare paure irrazionali o per sostenere agende politiche precostituite.
Il catastrofismo mediatico, infatti, oltre a disorientare l’opinione pubblica, finisce per danneggiare la stessa causa ambientale, che viene percepita come una crociata ideologica anziché come una sfida comune e pragmatica. È urgente che il giornalismo riscopra la sua funzione originaria: informare in modo onesto, verificato, sobrio e responsabile. Solo così sarà possibile ricostruire un rapporto di fiducia con il pubblico e contribuire a una reale consapevolezza sui problemi del nostro tempo, evitando derive emozionali e allarmismi che, spesso, fanno più male che bene.