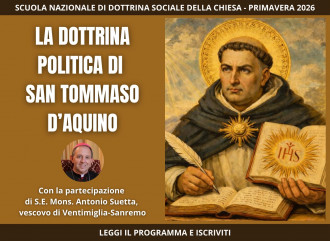Altari mobili = altari profani? Un’equazione sconfessata dalla storia
Gli altari mobili dei primi secoli cristiani non erano destinati a usi profani, come molti hanno ritenuto in epoca contemporanea. Essi erano trasportabili sia per proteggerli da eventuali profanazioni sia soprattutto perché erano legati al vescovo.

La convinzione che, nei primi secoli del cristianesimo, non esistessero altari sacri, ma piuttosto mense utilizzate per scopi profani e al bisogno adattate per la celebrazione dell’Eucaristia, non di rado ha esibito come supporto storico l’esistenza degli “altari itineranti”, ossia altari che potevano essere spostati. La situazione sembra essere stata differente a seconda delle regioni geografiche: in alcune zone, come la Siria e la Palestina, veniva privilegiato l’altare fisso; in altre, altari parzialmente mobili, ossia altari di legno o pietra con quattro gambe, che venivano inserite in appositi fori, senza però essere fissate al pavimento. Non mancano in effetti le testimonianze di altari che potevano essere rimossi, se necessario, come per esempio per sottrarli ad eventuali profanazioni. Ma anche di altari che, come vedremo tra poco, “seguivano” il vescovo.
L’equazione che normalmente viene proposta suona più o meno così: altare mobile=altare profano. L’idea che la tavola utilizzata per deporvi il pane e il vino per la liturgia non fosse fissata, ma mobile, ha fatto ritenere che si trattasse appunto di tavole dall’uso misto, liturgico e profano, e pertanto non fossero sacre, ossia riservate all’azione liturgica. Negli anni ‘70 e ‘80 del Novecento, con il vento della follia liturgica in poppa, in molte chiese si sono accantonati e persino distrutti antichi altari, per sostituirli con tavolini mobili, con la scusa di riprendere le orme della Chiesa dei secoli pre-costantiniani, periodo in cui – si riteneva – si celebrava nelle case, su semplici tavole utilizzate come mensa familiare.
L’equazione appare però decisamente approssimativa e sbrigativa, e la sua applicazione “creativa” decisamente fuori posto e irritante. L’esistenza di altari mobili, infatti, non testifica affatto la loro profanità. Altari mobili eppure destinati esclusivamente al culto esistevano infatti già nei culti pagani, ma soprattutto nel culto giudaico. Dio aveva infatti comandato a Mosè di realizzare stanghe di legno di acacia, ricoperte d’oro per trasportare la tavola su cui venivano collocati i dodici pani che dovevano stare alla sua presenza (cf. Es 25, 28-30). Nessun dubbio che l’altare dei pani di proposizione fosse oggetto sacro: proprio a causa della sua sacralità poteva essere trasportato solo dai leviti, senza essere toccato con le mani, ma appunto tramite queste aste dorate. Le stesse premure erano dovute all’altare dei sacrifici, dentro il recinto sacro, antistante al santuario, che doveva essere trasportato quando la nube della presenza del Signore si alzava per indicare al popolo che doveva riprendere la marcia nel deserto: «Farai anche delle stanghe per l'altare: delle stanghe di legno d'acacia, e le rivestirai di bronzo. Si faranno passare le stanghe negli anelli; le stanghe saranno ai due lati dell'altare, quando lo si dovrà portare» (Es 27, 6-7).
L’articolo potrebbe finire qui, constatando come certe conclusioni nascano più da un pregiudizio moderno contro il sacro, che non dalla testimonianza dei fatti della storia. Ma c’è qualcosa di più significativo che può e dev’essere compreso. Un testo dell’anonimo Ambrosiaster, o pseudo-Ambrogio, scritto a Roma attorno al 400 d. C., apre uno scorcio interessante: «nam útique et altare portárent et vasa eius, et aquam in manus fúnderent sacerdóti, sicut vidémus per omnes ecclésias» (CSEL 50, 195, cit. in STEFAN HEID, Altar und Kirche: Prinzipien christlicher Liturgie, p. 160, n. 548). I soggetti che portano l’altare e i vasi sacri sono i diaconi. Il testo permette alcune considerazioni degne di note: 1. l’altare poteva essere trasportato; questo non significa ovviamente che tutti gli altari fossero itineranti, ma che certamente esistevano tali altari “mobili”; 2. l’altare e i vasi utilizzati per la liturgia dovevano essere trasportati dai diaconi, non da chierici minori (la cui esistenza è già attestata nella Chiesa di Roma), né tanto meno da laici; si nota qui una stretta somiglianza con l’ordine impartito da Jahvé riguardo al trasporto degli altari del tabernacolo, riservato esclusivamente ai leviti; 3. si tratta non di un caso isolato, ma di una consuetudine che l’autore testimonia esser presente in tutte le chiese.
Questi elementi sono sufficienti per farci comprendere che la trasportabilità dell’altare non equivaleva affatto alla sua profanità. Ma perché questi altari dovevano essere trasportati? L’attenzione a proteggerli da eventuali profanazioni è una risposta solo parziale; la ragione più profonda sta nel fatto che, come abbiamo già avuto modo di vedere, l’altare era legato al vescovo: un vescovo, un altare. La partecipazione all’unico altare, davanti al quale sacrificava l’unico vescovo (evidentemente, uno per ogni città), era il segno dell’appartenenza all’unico Signore Gesù Cristo; al contrario, la partecipazione all’altare dei pagani o ai nuovi altari eretti da vescovi scismatici, e dunque alle loro celebrazioni, significava la rottura della comunione con Cristo.
L’altare doveva essere trasportabile perché era l’insegna, insieme alla cattedra, dell’ufficio e dell’autorità episcopale. Pertanto, quando il vescovo si recava al di fuori della “sua” chiesa, la cattedrale, per l’offerta del sacrificio, i diaconi lo seguivano trasportando l’altare “mobile”. Si trattava probabilmente di un altare più leggero e maneggevole rispetto a quello installato nella cattedrale, ma era pur sempre un altare sacro.
Questa consuetudine è attestata anche da una lettera di san Cipriano di Cartagine a papa san Cornelio, che si colloca tra il 251 e il 253 d. C., anni del pontificato di Cornelio. Il vescovo si spostava non verso la destinazione di presunte e indimostrate “chiese domestiche”, bensì verso le chiese martiriali, ossia oratori edificati in prossimità del luogo del martirio dei campioni della fede, ove il vescovo celebrava il sacrificio nel giorno memoriale del loro trionfo.
È chiaro che quanto detto presuppone una verità che a noi suona un po’ strana, ma che è nondimeno attestata da diversi scritti cristiani antichi: di norma, nei primi secoli, e probabilmente fino al Medioevo inoltrato, l’unica azione liturgica domenicale era quella presieduta dal vescovo nella chiesa cattedrale. Tutti i cristiani della città e delle zone suburbane erano chiamati a convenire e prendere parte all’unica celebrazione episcopale. Questa verità, che andremo a sostanziare nel prossimo articolo, comporta delle conseguenze piuttosto importanti, che rovesciano il modo con cui di consueto pensiamo alla vita liturgica dei primi secoli dell’era cristiana: nessuna pluralità di celebrazioni intime e “familiari” nelle presunte numerose chiese domestiche sparse per la città, ma un’unica grande celebrazione solenne presieduta dal vescovo. Ed una conseguenza della conseguenza: la liturgia è nata già solenne, standardizzata, sacra.