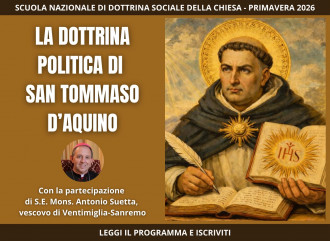Vangelo e Costituzione, il progressismo liberal di Lorefice
Ascolta la versione audio dell'articolo
“In una mano il Vangelo e nell’altra la Costituzione”, questo il titolo del discorso pronunciato il 30 ottobre dall’arcivescovo di Palermo, che dà un ritratto poverissimo di Gesù (senza mai dire che è Dio) ed esalta come non mai la Carta fondamentale. Un armamentario di slogan liberal.

Il discorso pronunciato il 30 ottobre scorso da mons. Corrado Lorefice in occasione del decimo anniversario della sua elezione ad arcivescovo di Palermo è di quelli che ti lasciano a bocca aperta e in grande difficoltà a raccapezzarti e a trovarne il bandolo. Fin dal titolo – “In una mano il Vangelo e nell’altra la Costituzione” – si poteva capire cosa sarebbe stato il brodo di cottura dell’intervento. Il tutto è avvenuto in occasione del Dies Academicus dell’Università di Palermo, in un contesto che si potrebbe chiamare scientifico, quindi con delle attese circa il livello dei discorsi d’occasione. La Giornata prevedeva, a dire il vero con una scelta non molto originale data la nota identità dossettiana del vescovo, le relazioni di Andrea Riccardi e di Alberto Melloni su pace e dialogo nella Nostra aetate del Vaticano II. Però è da pensare che perfino la Comunità di Sant’Egidio e la Scuola di Bologna si aspettassero dal discorso del vescovo qualcosa di più.
Occupandosi del primo dei due strumenti che mons. Lorefice, a suo dire, tiene nelle proprie mani episcopali, il vescovo ha nientemeno tentato di rispondere alla domanda «che cos’è il Vangelo?». E qui una valanga di slogan adoperati, come si fa largamente oggi, per dire altro da quello che dicono e far passare surrettiziamente aperture di processi pericolosi.
Lorefice dice che «il Vangelo non è una mera dottrina» per dire che non ha una dottrina; che «non è una serie di norme» per dire che non ci sono regole fisse nella Chiesa; che «non è una fonte immediata della morale» per sostenere che non ha una morale; che «non è l’ispirazione diretta di una politica» per negare l’obbligo dei politici di essere coerenti quando si votano le leggi; che «non è un possesso da conquistare» per negare il valore dell’apologia e della difesa della dottrina della fede; che «non è un’arma da brandire» per dire basta a condanne e giudizi sui peccati; che «il Vangelo non separa, non distingue, non separa il grano dalla zizzania» per dire che bisogna accogliere l’omosessualità e tutte le altre nuove «identità»; che «non è il vessillo di nessuna identità» per dire che bisogna accogliere tutte le identità tranne quella cristiana; che «non è un sistema filosofico» per dire che può andare d’accordo con tutte le filosofie e che è ora di finirla con san Tommaso; che «non è la sorgente di un monolite dogmatico senza storia» per dire che è ora di cambiare il Catechismo ben più in là dei paragrafi sulla pena di morte; che non parla «dell’uomo in generale» per dire che la legge morale è astratta e che ogni situazione è una eccezione.
Per spiegare meglio il Vangelo, Lorefice ha poi dipinto al modo di una telenovela televisiva Gesù Cristo: «un giovane uomo nato in Galilea e morto in croce a Gerusalemme, un uomo che è stato bambino, ha avuto due genitori e una grande famiglia, ha scoperto il senso di una presenza speciale di Dio nella sua esistenza, fino a farglielo chiamare “Papà” (Abbà), e per questo ha intrapreso un cammino nella Palestina del tempo». In nessun passaggio si parla di Gesù Cristo come di Dio, ma solo e sempre di un uomo che «ha vissuto un’esistenza da vero amante della vita, da amico delle donne e dei bambini, da compagno dei pubblicani e delle prostitute» e che ha annunciato «la prossimità di Dio agli uomini». Come ha «scoperto» il senso di Dio nella sua esistenza, Gesù avrebbe anche «confidato» nella «energia di risurrezione annidata nella sua morte». Qui Gesù Cristo non è la Sapienza eterna di Dio, l’Onnisciente, ma un uomo che «scopre» e «confida», esattamente come noi. Egli annuncia non Dio e il suo Regno ma l’»esserci per gli altri», l’altruismo umano.
Da questa povera visione di Nostro Signore Gesù Cristo si passa alla Costituzione, che solitamente il vescovo di Palermo tiene nell’altra mano come un altro Vangelo. Anche essa è un «racconto», anch’essa è uno «scritto profetico», anche essa è nata da un travaglio come l’Esodo biblico, anche essa esprime un bisogno di giustizia [attenzione al salto mortale!] come la natura intera secondo san Paolo. Qui abbiamo superato di gran lunga sia Roberto Benigni («La più bella del mondo») sia Luca Sommi («La più bella») sia Sergio Mattarella. La Costituzione, a questo punto, non può essere modificata da un referendum, anche se costituzionale, non deve rendere conto a qualcosa che la precede, per esempio il diritto naturale, niente di male se non riconosce l’indissolubilità del matrimonio né se dalla sua interpretazione sono state approvate leggi disumane: «Vedo la Costituzione insomma come il punto finale (e pur sempre provvisorio) di un lungo cammino, durato millenni, di Homo sapiens (ma già dei suoi contemporanei e predecessori, dai Neanderthal agli Erecti) verso una autocomprensione profonda di sé, una ricerca di un senso collettivo e individuale dell’esistenza, che approda a un testo sublime per apertura di orizzonti». Insomma, la Costituzione come filosofia e teologia della storia.
Tutto l’armamentario ormai classico del progressismo liberal è presente nel discorso di Palermo, scendendo anche a esemplificazioni politiche attuali: la lode a Barack Obama e al «Green Deal dell’Unione europea»; la condanna per il «folle estremismo politico-religioso del movimento MAGA» e per «la crisi dell’ambientalismo e l’abbandono della cura della Terra quale stella polare delle politiche planetarie».
Per fortuna che – a vedere le fotografie ufficiali dell’evento – in sala c’erano pochissime persone.