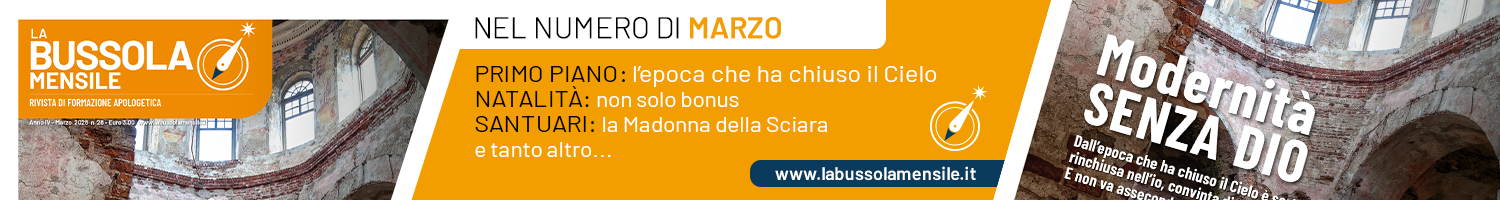Rai nelle mani del governo? Grazie a una legge della sinistra
Ascolta la versione audio dell'articolo
Una parte consistente della sinistra accusa il centrodestra di piegare la Rai agli interessi della maggioranza di governo, ma dimentica che è stata una legge votata dal centrosinistra – la riforma Renzi – a dare agli esecutivi maggiori poteri sul servizio pubblico.

A dieci anni dall’approvazione della legge n. 220 del 28 dicembre 2015 sulla Rai, voluta dal governo guidato da Matteo Renzi, il dibattito sul controllo politico della televisione pubblica torna di estrema attualità e assume contorni paradossali. Oggi una parte consistente della sinistra accusa il centrodestra di aver trasformato la Rai in “TeleMeloni”, denunciando un uso piegato agli interessi della maggioranza di governo, ma raramente ricorda che proprio quella legge, approvata dieci anni fa con il sostegno determinante del centrosinistra, ha fornito agli esecutivi strumenti molto più incisivi per orientare la governance e, indirettamente, l’indirizzo editoriale del servizio pubblico.
La riforma Renzi venne presentata come un passaggio storico per modernizzare l’azienda, renderla più efficiente, manageriale e finalmente autonoma dai partiti, superando la tradizione della lottizzazione parlamentare. Nelle intenzioni dichiarate, la Rai avrebbe dovuto diventare una media company competitiva, meno ingessata e sottratta ai condizionamenti politici. Tuttavia, col senno di poi, è evidente che quell’obiettivo non è stato raggiunto e che la nuova architettura istituzionale ha finito per accentuare la dipendenza dell’azienda dall’esecutivo.
La legge del 2015 ha ridisegnato la governance riducendo il Consiglio di amministrazione a sette membri e attribuendo al governo un ruolo centrale nella nomina dell’amministratore delegato, figura alla quale sono stati conferiti poteri molto ampi in termini di gestione, organizzazione e indirizzo strategico. Questo spostamento dell’asse decisionale dal Parlamento al governo ha reso la Rai più esposta alle maggioranze di turno, comprimendo gli spazi di mediazione e rafforzando il controllo dell’esecutivo su un’azienda che dovrebbe essere, per definizione, al servizio dei cittadini.
Non è dunque sorprendente che, nel corso degli anni, tutti i governi che si sono succeduti abbiano utilizzato la Tv pubblica come strumento di legittimazione e comunicazione politica: lo hanno fatto i governi a guida Renzi, lo hanno fatto quelli guidati da Giuseppe Conte e lo ha fatto anche il governo Draghi. Non perché esistesse una forzatura o un abuso eccezionale, ma perché la legge lo consentiva, anzi lo rendeva strutturalmente possibile. In questo senso, l’attuale polemica sulla presunta egemonia del centrodestra sulla Rai appare quantomeno incompleta se non ipocrita, perché ignora la responsabilità originaria di chi ha costruito un modello di governance che concentra il potere nelle mani dell’esecutivo.
Oggi il Parlamento discute nuovamente di riforma della Rai e le proposte arrivano da tutti gli schieramenti, ma il cuore del problema continua a essere eluso: non si tratta di stabilire quale partito o quale coalizione debba controllare la Rai, bensì di individuare la modalità più efficace per sottrarla a qualunque forma di controllo politico, come peraltro richiesto anche dall’articolo 5 dell’European Media Freedom Act (EMFA), regolamento europeo che impone agli Stati membri di garantire l’indipendenza dei media pubblici attraverso procedure di nomina trasparenti e criteri basati sulla competenza e sull’autonomia editoriale. Eppure, gran parte delle iniziative legislative continua a ragionare in termini di equilibrio tra maggioranza e opposizione, perpetuando una logica spartitoria che comprime il pluralismo interno e condiziona la distribuzione delle risorse editoriali secondo convenienze politiche più che secondo le reali esigenze informative del Paese.
Finché la composizione degli organi di vertice rifletterà accordi tra partiti, la Rai resterà un terreno di conquista e non un autentico servizio pubblico. Se davvero si vuole voltare pagina, occorre un cambio di paradigma radicale, che rompa il legame tra politica e nomine. Un modello coerente con l’EMFA potrebbe prevedere un sistema di selezione totalmente sganciato dai partiti, fondato su requisiti oggettivi, verificabili e pubblici, come l’istituzione di un elenco nazionale di figure qualificate del mondo della cultura, dell’informazione e del management, dal quale estrarre i vertici della Rai attraverso procedure trasparenti, persino mediante sorteggio pubblico. Un meccanismo di questo tipo ridurrebbe drasticamente le interferenze politiche e sposterebbe l’attenzione dal criterio dell’appartenenza a quello del merito. L’esperienza della BBC, pur con i suoi limiti, dimostra che è possibile costruire un servizio pubblico in cui l’influenza diretta dell’esecutivo sia contenuta da regole di governance pensate per tutelare l’autonomia editoriale. In Italia, invece, il nodo resta culturale prima ancora che normativo: la difficoltà ad accettare che la Rai non appartenga ai partiti ma ai cittadini.
A dieci anni dalla legge Renzi, il vero bilancio da fare è questo: la riforma non ha liberato la Rai dalla politica, ne ha semplicemente spostato il baricentro, rafforzando il governo a scapito del Parlamento e aprendo la strada a quelle accuse di propaganda che oggi animano il dibattito pubblico. Riconoscere questo dato è il primo passo per una riforma autentica, capace di restituire alla Rai credibilità, autorevolezza e indipendenza, trasformandola finalmente in un presidio democratico e non nel megafono di chi, di volta in volta, occupa Palazzo Chigi.