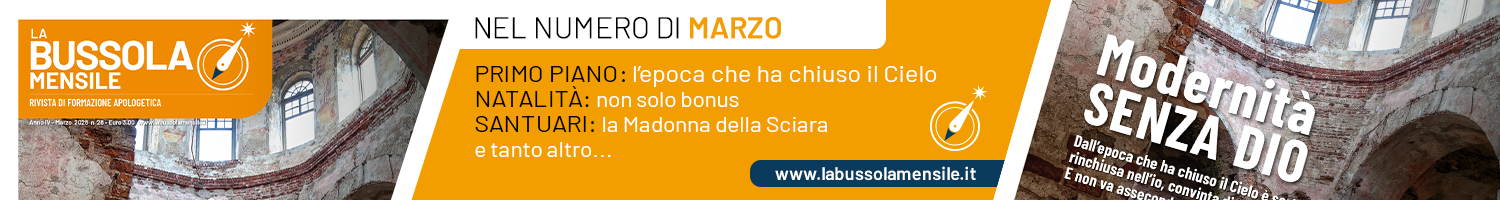Polidoro e la fortuna letteraria degli uomini-pianta
Dai versi di Virgilio nell’Eneide, con l’episodio di Polidoro ucciso dallo zio, nasce l’immagine dell’uomo-pianta che parla. Un’immagine che affascinerà i grandi letterati italiani, su tutti Dante e Tasso, con il primo che la riprenderà nel canto dell’Inferno con protagonista Pier della Vigna e il secondo nella scoperta fatta da Tancredi presso la selva di Saron.

L’episodio di Polidoro trasformato in pianta è uno dei meglio riusciti dell’Eneide, ricco di una fortuna letteraria che si è protratta nei secoli. Dai versi virgiliani nasce l’immagine dell’uomo-pianta cui viene strappato un ramo e che parla: un’immagine che affascinerà i grandi letterati italiani, su tutti Dante e Tasso che la richiameranno rispettivamente nell’Inferno e nella Gerusalemme liberata. Ma ci torneremo più tardi.
Il racconto di Enea a Didone prosegue all’inizio del III libro dell’Eneide come una lunga analessi. Fuggiti dalla madrepatria in fiamme, Enea e i Troiani approdano sulle coste della Tracia. Qui, desiderando sacrificare un toro a Venere, innalzano un altare e cercano del fogliame per ricoprirlo. Enea cerca di strappare con tutte le energie dei rami per coprire l’altare. Lo sforzo è sottolineato non solo dal verbo («conatus» ovvero «dopo aver tentato»), ma anche dall’espressione iperbolica per cui il ramo appare come un bosco («silvam»), tanto è difficile strapparlo. A questo punto accade un fatto sorprendente («monstrum»), spaventoso tanto da far rizzare i capelli («horrendum»), che desta ancora meraviglia ora che Enea lo racconta («dictu […] mirabile»): dal ramo strappato escono gocce di sangue che macchiano la terra.
La reazione emotiva di Enea è immediata, descritta con un’efficacia plastica che la traduzione italiana non riesce a trasmettere: «mihi frigidus horror/membra quatit gelidusque coit formidine sanguis» ovvero «un freddo terrore mi scuote le membra e il gelido sangue si raggruma per la paura». Del resto, tutto l’episodio ha una carica, una forza comunicativa, un’icasticità nei versi in lingua originaria che qualsiasi traduzione non può trasmettere. Per quali ragioni? Non solo per la pregnanza del lessico latino utilizzato da Virgilio, non solo per la concretezza della lingua dei nostri antenati, ma anche per una possibilità che il latino possiede e che le lingue contemporanee non hanno: le parole possono essere disposte dal poeta dove lui vuole, per enfatizzare, trasmettere, comunicare; il lettore in ogni caso intenderà il significato (perché la presenza dei casi nella lingua latina permette di cogliere le funzioni logiche, le associazioni tra aggettivi e sostantivi e tutte le altre componenti sintattiche necessarie per costruire la frase) e sorprenderà una miriade di sfumature in base alla disposizione delle parole.
Enea prova di nuovo a strappare un ramo con l’intento di comprendere la provenienza di quel sangue. E, poi, per la terza volta e con maggiore sforzo spezza il legno, quando un gemito misto a lacrime si ode dal tumulo di sabbia in cui è radicato il cespuglio. Subito dopo quel gemito si traduce in parole. Il cespuglio chiede a Enea: «Quid me miserum Aenea laceras?» che, tradotto in italiano, significa: «Perché laceri, o Enea, me misero?». Il cespuglio chiede all’eroe di non macchiare le sue mani pie, perché anche lui (che ora ha forma di cespuglio) è un troiano, della stessa patria. Dopo pochi versi con l’escamotage tipico del teatro antico (l’agnizione) la pianta si presenta: «nam Polydorus ego» ovvero «infatti io sono Polidoro». Racconta che è il figlio minore di Priamo, re di Troia, e che è stato inviato dal padre con il tesoro della città di Troia per trovare rifugio presso lo zio Polimestore in Tracia, una volta che le sorti della roccaforte apparivano segnate. Sbarcato sulle coste con tutte le ricchezze, Polidoro viene ricoperto da una pioggia di dardi e si trasforma in pianta. Polidoro riflette sulla cattiveria che l’avidità insinua nell’animo umano: «quid non mortalia pectora cogis,/ auri sacra fames» cioè «a che cosa non induci tu, o esecrabile fame dell’oro, il cuore degli uomini» (versi che saranno ripresi da Dante nell’episodio di Stazio del Purgatorio).
Enea riporta quanto è accaduto al padre Anchise e agli anziani e chiede il parere. Tutti esprimono la stessa opinione: andarsene da quelle terre contaminate («pollutum hospitium») e ripartire per mare. Allestito il funerale, i Troiani riprendono il loro vagabondaggio per il Mediterraneo.
Dante riprende il III libro dell’Eneide (con la storia di Polidoro e il successivo assalto delle Arpie ai Troiani sulle isole Strofadi) nel canto XIII dell’Inferno che vede protagonista Pier della Vigna in cui il Dante viator viene più volte confrontato dal Dante auctor (lo scrittore) con la figura di Enea. Nella selva dei suicidi, invitato da Virgilio a strappare una pianta in modo tale che i suoi dubbi siano tutti troncati, Dante coglie un ramo «da un gran pruno», vede uscire del sangue e, nel contempo, sente una voce che domanda: «Perché mi schiante?» (v. 33). E poco dopo: «Perché mi scerpi?/ non hai tu spirto di pietade alcuno?» (vv. 35-36).
L’allusione di Dante al testo virgiliano non è un semplice sfoggio di cultura o solo un omaggio al maestro, ma ci vuole introdurre in un’atmosfera di misfatto, di oltraggio nei confronti dell’ordine naturale e divino. Il lettore del canto dantesco, richiamando alla memoria l’azione scellerata compiuta dallo zio Polimestore nei confronti di Polidoro, delitto che viola la pietas e i naturali rapporti di parentela, s’introduce in un’aura surreale, abitata in apparenza da fantasmi. Il bosco è, in realtà, la metamorfosi di chi ha compiuto un gesto altrettanto contro natura di quello di Polimestore che ha ucciso un nipote. Il confronto tra la Commedia e il modello virgiliano dell’Eneide è molto sottile e condotto anche nel paragone dei protagonisti dei due poemi. Dante auctor, infatti, confronta l’atteggiamento di Dante viator con la tradizionale pietas di Enea. Dopo che, su suggerimento del maestro, il Fiorentino strappa un arboscello, Pier della Vigna lo rimprovera più volte di non essere sufficientemente «pio». Virgilio, a sua volta, dinanzi alla pianta lamentosa rinfaccia a Dante di non aver letto e compreso bene la sua opera (e l’episodio di Polidoro).
Oltre 250 anni più tardi, nella Gerusalemme liberata (1581) Torquato Tasso (1544-1595) racconta la riconquista del Santo Sepolcro e della Città Santa ad opera dei cristiani. Una sera, il paladino cristiano Tancredi sorprende due saraceni mentre incendiano le torri di legno costruite per l’assedio, li insegue e, alla fine, ne raggiunge uno. Inizia uno strenuo combattimento che dura l’intera notte. Quasi all’alba Tancredi riesce a trafiggere l’avversario e, prima che muoia, gli toglie l’elmo e scopre che ha ferito mortalmente l’amata Clorinda, appartenente all’esercito musulmano. Battezzata da Tancredi in punto di morte, la donna muore.
Nei mesi successivi i soldati cristiani cercano invano di entrare nella selva di Saron, stregata da un incantesimo, per tagliare il legno che serva a costruire di nuovo le torri. Dopo mesi in cui è rimasto nella propria tenda, abbattuto nell’animo, Tancredi parte per affrontare la selva in cui appaiono ai soldati dinanzi agli occhi le lor paure più profonde. Tancredi arriva ad una radura, a forma di anfiteatro, al cui interno s’innalza un cipresso (simbolo della morte). Il paladino estrae la spada, colpisce la corteccia dell’albero e «allor, quasi di tomba, uscir ne sente/ un indistinto gemito dolente». La voce che esce dalla pianta rimprovera Tancredi:
[…] Ahi troppo […]
M’hai tu, Tancredi, offeso: or tanto basti.
Tu dal corpo, che meco e per me visse,
Felice albergo già, mi discacciasti:
Perché il misero tronco, a cui m’affisse
Il mio duro destino, anco mi guasti?
Dopo la morte gli avversarj tuoi,
Crudel, ne’ lor sepolcri offender vuoi?
(canto XIII, ottava LXII)
Le parole di Clorinda sono un’allusione all’episodio di Polidoro dell’Eneide prima ancora che al canto di Pier della Vigna: la presenza dell’aggettivo «infelice» (miserum in latino) tradisce il richiamo di Tasso direttamente alla fonte letteraria virgiliana. Ma nel seguito delle parole di Clorinda l’atmosfera è tutta dantesca:
Clorinda fui: né sol qui spirto umano
Albergo in questa pianta rozza e dura:
Ma ciascun altro ancor, Franco o Pagano,
Che lassi i membri a piè dell’alte mura,
Astretto è qui, da novo incanto e strano,
Non so, s’io dica in corpo, o in sepoltura.
Son di senso animati i rami e i tronchi,
E micidial sei tu, se legno tronchi.
(canto XIII, ottava LXIII)
Quell’incipit d’ottava riecheggia le parole di Pier della Vigna: «Uomini fummo, e or siam fatti sterpi». Inoltre, come la selva dei suicidi è tutta composta di anime che si sono macchiate di quella colpa, anche la selva di Saron, a detta di Clorinda, è costituita dai guerrieri che muoiono combattendo ai piedi delle mura di Gerusalemme, a qualunque schieramento appartengano. Un dato simbolico ci permette di capire che Tasso ha voluto ricreare l’atmosfera dantesca: è il numero del canto in cui il poeta ha inserito l’episodio di Clorinda, il tredicesimo, proprio come il canto di Pier della Vigna.