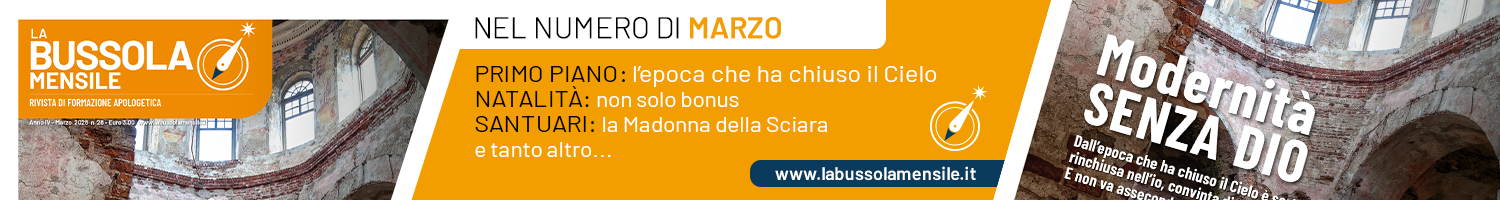Ottant'anni fa la resistenza della Chiesa al terrore di Tito
Ascolta la versione audio dell'articolo
Di fronte alla ferocia degli invasori jugoslavi, vescovi e sacerdoti eressero l'ultimo presidio di libertà, tessendo reti di soccorso e denunciando il terrore comunista e l'ateismo di Stato. Una drammatica pagina di storia, culminata nella tragedia delle foibe e nell'esodo istriano, troppo a lungo censurata in nome della convenienza politica.

Tra l’autunno del 1943 e il 1948, il confine orientale italiano — tra Istria, Fiume e Dalmazia — fu teatro di una spietata pulizia etnica e politica orchestrata dalle milizie comuniste del maresciallo Tito. Il bilancio è una ferita nazionale: 350.000 esuli e oltre 20.000 vittime, cancellate per sradicare l’identità italiana e abbattere ogni resistenza all’annessione jugoslava.
Simbolo di questo sterminio sono le foibe: crepacci naturali del Carso, imbuti di roccia profondi fino a 200 metri sotto terra. La tecnica di morte ideata dalle milizie comuniste era di una ferocia terribile: i prigionieri venivano legati ai polsi col filo spinato e allineati sull’orlo delle foibe; i miliziani sparavano solo ai primi della fila, che precipitando trascinavano con sé nel vuoto l’intera catena di uomini ancora vivi. Molti non morivano sul colpo, ma restavano ad agonizzare per giorni nel buio, sepolti vivi sotto quintali di detriti e corpi. Al Pozzo di Basovizza, per fare un esempio, profondo 250 metri, furono trovati quattrocento metri cubi di resti umani, poi sigillati con esplosivi per occultare la strage.
Questa tragedia, rimasta per decenni nel silenzio, è oggi solennemente rievocata dal Giorno del Ricordo, il 10 febbraio, istituito con legge dello Stato nel 2004. La strategia degli invasori jugoslavi fu chirurgica: colpire i pilastri della società civile per annientare l’identità italiana. Intellettuali, medici e insegnanti finirono nelle liste di proscrizione, ma una particolare crudeltà fu riservata ai sacerdoti. Per le milizie comuniste di Tito, i sacerdoti non erano solo ministri di un culto avversato dall’ateismo comunista, ma gli ultimi punti di riferimento di una popolazione profondamente religiosa.
E mentre l’apparato militare e civile italiano svaniva, i vescovi e i sacerdoti rimasero l’unico argine. Furono gli “uomini in nero” a tessere una rete clandestina di soccorso che permise a 350.000 italiani di mettersi in salvo. La risposta di Tito fu una persecuzione sistematica: i consacrati vennero bollati come “insetti” da eliminare, non si contano i seminaristi e le suore che sparirono nel nulla e numerose chiese furono rase al suolo per sradicare la memoria storica dei luoghi.
Il conflitto tra fede e ideologia a Fiume esplose il 22 giugno 1946, festa del Corpus Domini. Nel tentativo di minare l'unità ecclesiale, il regime dichiarò la giornata lavorativa — da sempre radicata nel calendario civile come giorno festivo — minacciando licenziamenti e la revoca delle tessere annonarie per chiunque avesse disertato il posto di lavoro. Nonostante le intimidazioni, la popolazione fiumana scelse la disobbedienza civile di massa. Migliaia di cittadini si riversarono nelle strade circondando la Cattedrale di San Vito.
Sfidando apertamente il diktat del regime, il vescovo Ugo Camozzo (nella foto) scelse di non indietreggiare, guidando la processione solenne attraverso una città sospesa tra devozione e terrore. Fu un corpo a corpo spirituale: lungo il percorso, miliziani in borghese e attivisti comunisti bersagliarono il clero con una pioggia di pietre e rifiuti. Testimoni oculari ricordano la figura di monsignor Camozzo avanzare imperturbabile tra i fumi dell’odio, le mani strette attorno all’ostensorio nel tentativo di proteggerlo sotto il baldacchino, mentre il fragore delle preghiere e dei canti dei fedeli si alzava come un muro sonoro per coprire gli insulti e le urla degli aggressori.
Fu l’ultimo atto di libertà dell’identità cattolica italiana a Fiume. Prima dell’esilio, monsignor Camozzo compì un gesto profetico: divise il Tricolore in tre lembi, nascondendoli tra le pagine del breviario per eludere i controlli jugoslavi. Nominato arcivescovo di Pisa nel 1948, Camozzo divenne il “vescovo degli esuli”, opponendo un fermo rifiuto diplomatico al regime comunista. Attraverso una tenace pressione internazionale, riuscì a strappare ai campi di lavoro jugoslavi 27 tra sacerdoti e seminaristi, portandoli in salvo. Nelle sue lettere pastorali non smise mai di dar voce ai fiumani.
Nella galleria dei martiri del regime di Tito, svetta anche la figura di monsignor Antonio Santin, vescovo di Trieste e Capodistria. Il suo “venerdì di passione” scoccò il 19 giugno 1947, festa del patrono San Nazario: un’ultima occasione di identità per gli italiani e un dovere pastorale per il vescovo, deciso ad amministrare, quello stesso giorno anche le cresime nonostante i divieti. «Andrò, anche a costo della vita», dirà.
L’agguato fu pianificato con ferocia all’interno del seminario, dove il vescovo si stava preparando per la funzione. Non fu un tumulto spontaneo, ma un assalto coordinato da miliziani comunisti slavi e agitatori.
Mons. Santin ricordò così quegli istanti: «Mi trovarono, mi insultarono, gridando che dovevo andarmene... Mi trascinarono violentemente giù per le scale del seminario percuotendomi con pugni e con legni sulla testa. Arrivai in cortile perdendo mozzetta, rocchetto, croce e scarpe. Ero tutto insanguinato». Sopravvissuto a un linciaggio e a un tentativo di accoltellamento, poco dopo, monsignor Santin sventò l’ultima trappola di chi voleva annegarlo con una pietra al collo, scegliendo di rientrare via terra in piedi su un camion, bersagliato dalle pietre.
Tornato a Trieste, la sua cattedrale di San Giusto divenne un presidio di libertà. Da quel pulpito, nel 1948, monsignor Santin non cessò mai di condannare il “regno del terrore comunista” e l’ateismo di Stato. E arrivò a proibire la lettura della stampa comunista.
Ma la sua resistenza non si limitò alla parola. Insieme a don Pietro Damiani, il vescovo Santin ideò un canale sotterraneo di soccorso che, attraverso un drammatico appello via radio, riuscì a strappare alla miseria e alla morte oltre mille bambini. Fu il sacerdote che non indietreggiò, dimostrando che se il comunismo poteva occupare le terre, non era ancora riuscito a piegare le anime.
In quel clima di terrore, l’esodo di massa divenne l’unica via di fuga da una sistematica persecuzione etnica e ideologica che vedeva le milizie comuniste di Tito colpire non solo i cittadini italiani, ma anche i loro sacerdoti, trasformati in bersagli privilegiati di una violenza mirata a sradicare ogni traccia di identità religiosa e nazionale.
Ma il paradosso storico toccò l’apice sulle colonne de L’Unità — organo ufficiale del partito comunista italiano — del 30 novembre 1946, il dramma di 350.000 esuli veniva liquidato con un cinismo che ancora oggi sgomenta: «Non riusciremo mai a considerare aventi diritto ad asilo coloro che si sono riversati nelle nostre grandi città, non sotto la spinta del nemico incalzante, ma impauriti dall’alito di libertà che precedeva o coincideva con l’avanzata degli eserciti liberatori. […] non meritano davvero la nostra solidarietà né hanno diritto a rubarci pane e spazio che sono già così scarsi».
Per sessant’anni, questa pagina di storia patria è stata strappata dai libri, sacrificata sull’altare di una convenienza politica che preferiva il silenzio alla verità.