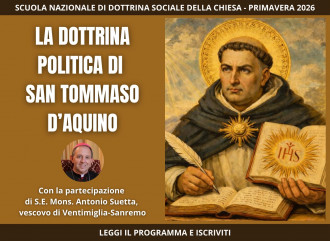Negando la trascendenza l'Europa nega anche la libertà
Ascolta la versione audio dell'articolo
Eliminati un principio superiore e un ordine naturale, resta una sovranità autoreferenziale che finisce per assolutizzarsi. Ecco perché la tendenza all'autoritarismo è insita nella struttura stessa dell'Unione Europea, quale volto politico dell'immanentismo.

L’Unione Europea non è semplicemente un costrutto politico o giuridico: è l’espressione compiuta di una metafisica dell’immanenza che, negando ogni fondamento ontologico e teleologico dell’ordine, finisce per tradursi in una forma di autoritarismo necessario. Non un autoritarismo nel senso empirico del dominio (almeno per ora), bensì come esito teoreticamente ineluttabile di una razionalità che, avendo reciso ogni partecipazione dell’essere umano a un principio superiore, si trova costretta a sostituire alla verità del reale la coerenza del sistema. In questo senso, l’Unione Europea non rappresenta una deviazione dall’idea di libertà, bensì la sua radicale autonegazione: è la libertà dell’indifferenza che, priva di misura, si converte in dominio della forma.
Il processo di integrazione europea si muove interamente entro l’orizzonte della modernità politica, che ha dissolto la distinzione classica tra auctoritas e potestas. Là dove la auctoritas era partecipazione alla verità e, quindi, fondamento del diritto come ordinamento del giusto, la potestas moderna è, invece, pura capacità di produrre effetti giuridici. La sua legittimità non risiede più nella conformità all’essere, quanto nella sua stessa effettualità. L’Unione Europea è, sotto questo profilo, l’oggettivazione di una volontà costruttivista che si auto-legittima attraverso il funzionamento delle proprie procedure. Ciò che vale è ciò che è deciso e ciò che è deciso è tale in quanto prodotto da una volontà formalmente competente. Il principio di attribuzione sancito dall’art. 5 del Trattato sull'Unione Europea è così trasformato in un atto di autoconferma: l’Unione determina la propria competenza, non per derivazione, ma per autoreferenzialità. La Kompetenz-Kompetenz è divenuta l’essenza stessa della sua forma.
Questa struttura è teoreticamente riconducibile a ciò che potremmo chiamare "immanentismo normativo". Il diritto, infatti, non deriva più da un ordine che lo precede, ma è prodotto nel movimento stesso della volontà politica. È un diritto che si fonda su se stesso, un ordo ordinatus ad se ipsum. La sua razionalità è puramente circolare, poiché non riconosce nulla che lo trascenda. In tal senso, l’Unione non ha abbandonato l’idea di sovranità: l’ha assolutizzata. Se lo Stato moderno aveva posto la sovranità nella decisione di un soggetto personale (il monarca, poi il popolo), l’Unione la colloca nella neutralità impersonale delle sue istituzioni, che proprio perché prive di volto appaiono come necessarie. Il potere, dissolta la trascendenza, diventa struttura.
Gli Stati membri non costituiscono un argine a questa deriva, poiché essi stessi sono figli dello stesso paradigma ontologico. Anch’essi si fondano su una concezione volontaristica del diritto, in cui la legge non è misura bensì atto di autodeterminazione. La loro opposizione all’Unione è di tipo funzionale, non sostanziale: non difendono un ordine naturale, bensì una propria porzione di potere immanente. Così, il conflitto tra sovranità nazionale e sovranità europea non è uno scontro tra due concezioni dell’ordine, ma la dialettica interna di una stessa filosofia della volontà. In entrambi i casi, la giuridicità è ridotta alla capacità di produrre effetti e la giustizia è dissolta nel gioco delle competenze.
L’autoritarismo europeo si manifesta, pertanto, come il volto politico dell’immanentismo filosofico. Il Rule of Law Mechanism, la condizionalità finanziaria, le normative vincolanti in materia ambientale, sanitaria, etica e tecnologica non sono segni accidentali di una tendenza centralizzatrice, ma il riflesso di una necessità teoretica: se non vi è un ordine naturale a cui l’azione politica possa riferirsi, l’unico ordine possibile è quello che il potere istituisce. La mancanza di trascendenza genera la necessità di totalità. Quando l’essere non è più il principio, la volontà diventa il tutto. Ecco la radice ultima della "voglia di autoritarismo": non un impulso politico contingente, ma l’esito ontologico di un pensiero che ha abbandonato l’idea di partecipazione all’essere per sostituirla con l’idea di costruzione del mondo.
In tale prospettiva, il diritto dell’Unione non è più lex rationis, ma lex voluntatis. La Corte di Giustizia di Lussemburgo, attraverso la propria giurisprudenza, ne è l’epifania più evidente: la sentenza Costa c. ENEL (C-6/64) ha sancito il primato del diritto dell’Unione sul diritto interno; Internationale Handelsgesellschaft (C-11/70) ha esteso tale primato anche sulle Costituzioni nazionali; Melloni (C-399/11) ha stabilito che gli Stati membri non possono applicare standard di tutela dei diritti fondamentali superiori a quelli fissati dal diritto dell'Unione, se questo compromette l'uniformità dell'ordinamento europeo. Queste pronunce non si limitano a stabilire regole di coordinamento, ma affermano una metafisica implicita: il diritto è tale non perché conforme al giusto, ma perché proveniente dall’istituzione che decide.
È il trionfo dell’ordo artificialis, dove la giustizia è ridotta a non-contraddizione sistemica e la Corte diviene l’organo teologico dell’immanenza: un potere che non giudica secondo la verità, quanto secondo la necessità della coerenza. Ciò che si annulla, in questa prospettiva, è la possibilità stessa di un ordo iuris come partecipazione all’ordine dell’essere. Il diritto naturale classico, che concepiva la legge come ordinatio rationis ad bonum commune, è stato sostituito da un diritto funzionale, che ordina non in vista del bene, ma dell’efficienza e dell’omogeneità. Tale sostituzione non è soltanto etica, bensì ontologica: essa implica la perdita del rapporto tra il diritto e il vero, tra la norma e la misura dell’essere.
La giustizia, privata del suo fondamento metafisico, diviene in questo modo un prodotto linguistico dell’amministrazione; la persona, non più immagine del Logos, si riduce a unità di imputazione e di consumo. Recuperare, allora, il diritto naturale non implica un ritorno sentimentale a un passato giuridico idealizzato, né una riedizione confessionale dell’ordine medievale; significa, invece, ripristinare la dimensione metafisica del diritto come partecipazione alla verità dell’essere. Esso non è una dottrina tra le altre, ma la condizione stessa della possibilità del giuridico come espressione della ragione ordinante. Laddove l’Unione Europea, e con essa gli Stati che la compongono, hanno ridotto la normatività a sistema di auto-validazione procedurale, il diritto naturale riafferma che l’ordine non è prodotto, ma riconosciuto; che la legge non nasce dalla decisione, ma dall’intelligenza dell’essere e dal suo orientamento al bene.
Solo in questa prospettiva il diritto può riacquistare il proprio statuto ontologico, ossia la propria realtà come ordo rationis, non come dispositivo funzionale. Ciò comporta una trasformazione più radicale di qualsiasi riforma istituzionale: un mutamento ontologico del pensiero politico europeo. Finché la auctoritas continuerà a essere concepita come mera funzione della potestas, l’Unione non potrà che oscillare tra il formalismo tecnocratico e la coercizione normativa. Riconoscere nuovamente che ogni ordinamento giuridico è giusto solo nella misura in cui partecipa dell’ordine del reale significherebbe rompere la circolarità dell’immanenza, aprendo lo spazio di una trascendenza razionale in cui il diritto torna a essere forma del vero, non semplice schema del possibile.
L’Europa, allora, potrà risorgere solo quando riconoscerà che la ragione non crea l’ordine, ma vi si adegua; che la legge non è volontà, ma intelligenza; che la giustizia non è costruzione, ma scoperta. In tal modo il diritto non sarà più il linguaggio del potere che si giustifica, bensì la voce della verità che ordina. Senza questa conversione metafisica, ovvero senza il ritorno a un realismo giuridico che concepisca la norma come partecipazione alla ratio divina e naturale, l’Europa rimarrà prigioniera del proprio apparato, costretta a sostituire la verità con la coerenza, la giustizia con l’efficienza, l’autorità con la gestione.