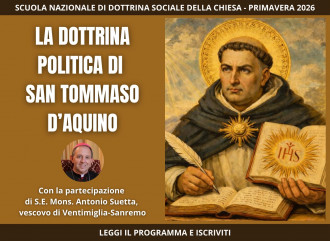Il timballo del Gattopardo, l’aristocrazia siciliana in un piatto
Ascolta la versione audio dell'articolo
Pubblicato postumo e primo best seller italiano, Il Gattopardo ci regala una delle immagini gastronomiche più sontuose della nostra letteratura: il timballo di maccheroni, che nel romanzo diviene il simbolo di un’epoca vicina al tramonto.

Eccoci alla prima puntata della rubrica La cucina letteraria: un viaggio tra parole e sapori. Iniziamo con uno dei piatti più sontuosi della narrativa italiana: il timballo di maccheroni descritto ne Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957).
Era il 1958 quando un manoscritto dimenticato in un cassetto, scritto da un aristocratico siciliano in punta di penna e sotto il velo del silenzio, cambiò per sempre il destino della letteratura italiana. Rifiutato da grandi nomi dell’editoria (Mondadori, Einaudi, Longanesi) per il suo stile ritenuto troppo ottocentesco, Il Gattopardo venne accolto dalla Feltrinelli grazie alla lungimiranza di Giorgio Bassani (1916-2000). Un anno dopo conquistava il Premio Strega e diventava il primo best seller italiano.
Un caso editoriale clamoroso: postumo, conservatore, decadente, ma capace di intercettare le contraddizioni di un’Italia sospesa tra il tramonto della nobiltà e l’alba del potere borghese. Il romanzo non solo riscrisse il finale della stagione neorealista, ma inaugurò l’era dei bestseller letterari, dimostrando che una scrittura di alta qualità poteva toccare il cuore di migliaia di lettori.
Quando Luchino Visconti portò sul grande schermo Il Gattopardo nel 1963, con un cast stellare composto da Burt Lancaster, Alain Delon e Claudia Cardinale, non fece che amplificare la potenza di un’opera letteraria già destinata all’immortalità.
Ambientato in una Sicilia che attraversa il Risorgimento e si affaccia alla modernità, il romanzo non è solo una cronaca storica: è una meditazione profonda sull’identità di un popolo, sulla decadenza di una classe sociale e sull’illusione del cambiamento.
Don Fabrizio, principe di Salina, osserva con sguardo lucido e disincantato il tramonto della nobiltà borbonica e l’ascesa di una nuova borghesia affaristica. Il suo giovane nipote Tancredi, garibaldino e poi ufficiale per i piemontesi, incarna la generazione che crede di poter cavalcare la Storia. Ma il cuore del romanzo pulsa altrove: nei silenzi della villa di Donnafugata, nei turbamenti amorosi, nei tradimenti e nei rimpianti, in quel senso di immobilità che avvolge la Sicilia come una nebbia millenaria. «In Sicilia non importa far bene o far male: il peccato che noi Siciliani non perdoniamo mai è semplicemente quello di fare», confessa Don Fabrizio al funzionario piemontese Chevalley. Una frase che racchiude l’anima del romanzo e il suo messaggio più profondo: la Storia può cambiare i governi, ma non sempre riesce a scalfire l’anima di un popolo.
Un linguaggio raffinato, di altra epoca, decadente ed esteta, seduce e accompagna il lettore, come quando l’autore descrive l’attesa dell’arrivo di Angelica al ricevimento: «L’attimo durò cinque minuti; poi la porta si aprì ed entrò Angelica. La prima impressione fu di abbagliata sorpresa. I Salina rimasero col fiato in gola […]. Sotto l’impeto della sua bellezza gli uomini rimasero incapaci di notare, analizzandoli, i non pochi difetti che questa bellezza aveva». Leggiamo poi la grazia della descrizione di Angelica: «Era alta e ben fatta, in base a generosi criteri; la carnagione sua doveva possedere il sapore della crema fresca alla quale rassomigliava, la bocca infantile quello delle fragole. Sotto la massa dei capelli color di notte avvolti in soavi ondulazioni, gli occhi verdi albeggiavano, immoti come quelli delle statue e, com’essi, un po’ crudeli». In queste righe Tomasi di Lampedusa arricchisce la sensualità della donna con toni sinestetici accostando il colore della pelle al sapore della crema e le labbra alle fragole. Non è l’unico momento del romanzo in cui lo scrittore presenta del cibo prelibato.
Nel cuore del celebre pranzo nel palazzo di Donnafugata, Il Gattopardo ci regala una delle immagini gastronomiche più sontuose della letteratura italiana: il timballo di maccheroni. Servito con solennità e accompagnato da un silenzio quasi religioso, il piatto diventa il vero protagonista della scena, un’opera d’arte nel piatto, profumata e barocca: «L’oro brunito dell’involucro, la fragranza di zucchero e di cannella che ne emanava, non era che il preludio della sensazione di delizia che si sprigionava dall’interno quando il coltello squarciava la crosta: ne erompeva dapprima un fumo carico di aromi e si scorgevano poi i fegatini di pollo, le ovette dure, le sfilettature di prosciutto, di pollo e di tartufi nella massa untuosa, caldissima dei maccheroni corti, cui l’estratto di carne conferiva un prezioso color camoscio».
Ne Il Gattopardo il timballo è molto più di una pietanza: è scenografia aristocratica, espressione estetica e dichiarazione di identità. Le tavole siciliane si trasformano in palcoscenici dove il cibo incarna gerarchia, rituale e resistenza al cambiamento. Il principe di Salina lo contempla come un affresco familiare: sontuoso e raffinato, ma malinconicamente legato a un mondo che sta svanendo. Con la sua crosta dorata profumata alla cannella, il timballo non nutre soltanto: seduce, racconta, conserva. È un monumentum nel senso etimologico: testimonianza che tramanda la Sicilia borbonica, tra bellezza decadente e orgoglio identitario. Sotto quella superficie fragrante, convivono le contraddizioni di un’isola che preferisce custodire la propria opulenza anziché piegarsi alla modernità.
Al suo interno, un concerto di sapori: maccheroni al dente avvolti da un ragù ricco, succulente polpettine di salsiccia o vitello, funghi trifolati, piselli, prosciutto cotto, rondelle di uova sode e, per i palati audaci, scaglie di tartufo. A racchiudere tutto, una crosta di pasta frolla salata, lievemente profumata alla cannella, che sigilla lo scrigno dorato. La cottura è lenta e solenne, il taglio delle fette è quasi cerimoniale, e ogni porzione sprigiona il racconto di un Sud elegante, passionale e stratificato.
Chi non ha mezza giornata da dedicare a questo monumento culinario può affidarsi a una versione casalinga: pasta corta tipo anelletti con ragù semplice, mozzarella, funghi, piselli e uova, il tutto racchiuso da melanzane grigliate e cotto al forno. Meno scenografico, forse, ma ugualmente capace di evocare quell’epoca in cui il pranzo era un romanzo, da gustare lentamente, pagina dopo pagina.