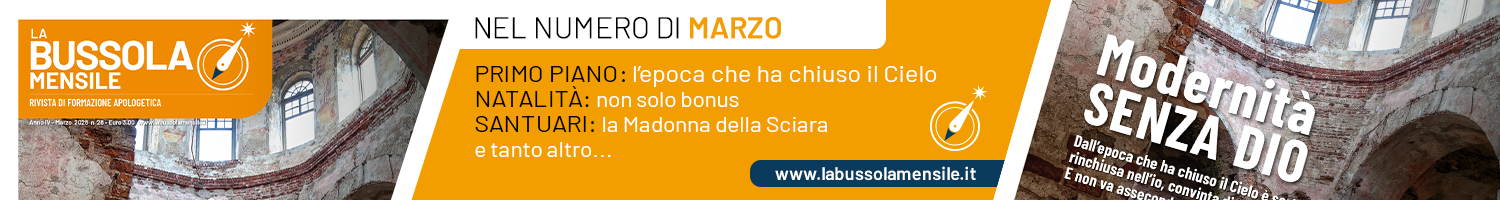Il filosofo Hadjadj spiega dove sta la vera gloria
Nel saggio A me la gloria, l’autore francese, com’è nel suo stile, procede per intuizioni, immagini e paradossi. La gloria dei pagani e quella dei cristiani non coincidono: per i primi la si conquista con uno sforzo; i secondi, invece, la ricevono in dono, purché ne riconoscano la sorgente.
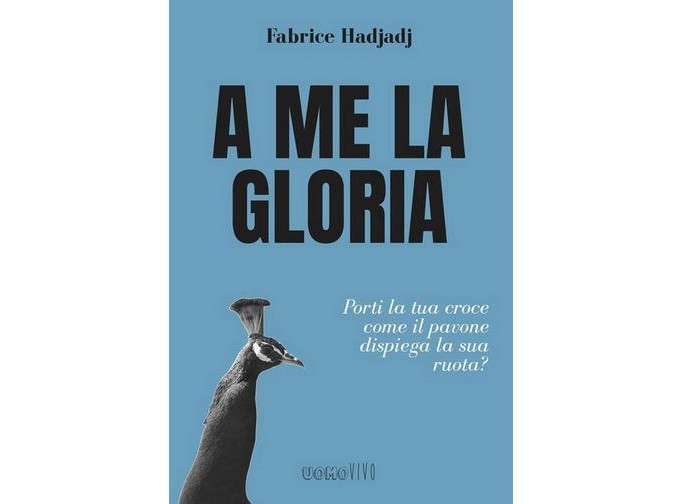
Fabrice Hadjadj vola sempre più alto. Dopo aver affrontato i nodi centrali dell’esistenza umana - morte (Farcela con la morte) e sessualità (Mistica della carne. La profondità dei sessi) in primis - il filosofo francese ora guarda soprattutto alla trascendenza. Ricavato da un ciclo di conferenze tenute nella Quaresima 2019, su invito del vescovo di Sion, A me la gloria (Berica Editrice, 2022) è l’ultimo saggio di Hadjadj tradotto in italiano.
In copertina campeggia l’immagine di un pavone, simbolo di bellezza e, al contempo, di vanità: l’autore, però, mette subito in chiaro che ogni creatura è riflesso della gloria di Dio. Il maschio dello stesso pavone, con la sua coda sgargiante e pesante, è una sfida per ogni darwinista: il suo aspetto fisico non ne garantisce la sopravvivenza ma lo rende “il miglior riproduttore”. Non tutto ciò che è intrinseco negli esseri viventi è finalizzato all’autoconservazione, altrimenti la sua vita “non ha più nulla a cui offrirsi, si ripiega su sé stessa e perciò si fossilizza”, osserva Hadjadj. A cosa servono, allora, la ruota del pavone o il canto del merlo? Essi fungono da rappresentazione o, se si preferisce, da “autopresentazione” della specie, sono “affermazioni della bontà dell’essere che ci saltano agli occhi e ci prendono alla gola”.
Il pavone, la rosa o il lapislazzuli testimoniano, ognuno a modo proprio, che “la terra è piena di una gloria divina”. Nessuna specie vivente è nel mondo semplicemente per “sopravvivere”, né ambisce all’immortalità: ognuna mira, piuttosto, alla “fruttificazione”, ad offrire una “manifestazione dell’Eterno, anche fosse attraverso quanto c’è di più effimero”. Il saggio di Hadjadj procede per intuizioni, immagini, provocazioni e paradossi, com’è nello stile dell’autore francese. Sullo sfondo, c’è sempre l’espressione ebraica kabod, che si traduce abitualmente come “gloria” o come “onore” ma, etimologicamente, richiama un “peso”. È qui la chiave cristologica dell’intero saggio: la “croce gloriosa” di Cristo. Se Cristo è il re della gloria, è inevitabile pensare che la sua gloria sia pesante. La gloria dei pagani e quella dei cristiani non coincidono: il pagano, per conquistare la gloria, deve compiere uno sforzo, un’elevazione agli dèi. Il cristiano, invece, la gloria la riceve in dono ma per farlo deve abbassarsi, umiliarsi, riconoscere la fonte di quella gloria, chinandosi sotto il suo peso.
L’umiltà cristiana non ha nulla a che vedere con una più o meno falsa modestia: del resto è la stessa Vergine Maria a riconoscere, nel Magnificat, che il Signore ha “guardato l’umiltà della sua serva” e, al tempo stesso, di “beneficiare della promessa fatta ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre (cfr. Lc 1,48 e 55)”. Si va incontro alla gloria, dunque, rimanendo umili, e ciò implica occupare la casella in cui ci si trova nel grande gioco della vita. Non solo “gli onori sfuggono a chi corre loro appresso” ma la “ricerca di grandi fatiche e di grandi pericoli può costituire una fuga davanti alle esigenze del quotidiano”. Per il cristiano, la “fatica di Ercole” è, in primo luogo, nell’“amare i propri nemici”. Eppure, si cade facilmente nel trabocchetto di cercare di “esercitare la mia carità nel profondo dell’Amazzonia pur di non cadere nell’ordinario di dover visitare la mia vecchia mamma che ho scrupolosamente abbandonato in una RSA della periferia parigina”.
Eroe non è chi cerca l’eroismo ma chi lo diventa “suo malgrado”, come gli hobbit tolkieniani, dei “mezzuomini” che amano la vita tranquilla e per i quali “non c’è niente di più bello che bere una birra o fumare la pipa tra amici, danzare con la propria donna alla festa del villaggio, raccontare una storia ai figli, coltivare l’orto e fare dolci”. Il miglior vescovo è colui che non vuol diventarlo, così come - secondo il paradosso di Platone - “i migliori governanti si trovano sempre tra i saggi che non hanno voglia di esserlo”.
La “gloria del Risorto”, oggetto dell’ultimo capitolo, spiana la strada verso una meta, che, in realtà, non è che un nuovo punto di partenza: la Resurrezione non si compie tra fuochi d’artificio ed effetti speciali ma nella quotidianità un po’ grigia che avevamo lasciato al momento della Via Crucis. Il Risorto si manifesta ai discepoli di Emmaus (che non l’avevano riconosciuto…) al momento della cena e trascorre buona parte dei suoi ultimi quaranta giorni con i discepoli, mangiando con loro, “anche se non c’è più bisogno di mangiare”: nulla di più umano e ordinario. La salvezza che il Risorto dona non è una “salvezza terapeutica” e l’uscita dal sepolcro non è “un’uscita dal dramma”. La gloria di Dio, cioè, “non sta tanto nella nostra liberazione quanto nella nostra vera libertà, in quel che potremmo chiamare il nostro incarico, il kabod della nostra responsabilità”, nella nostra “missione” come “cooperatori della salvezza”. È nel tenere vivo il Vangelo e nel portare la croce che risplende la nostra gloria.