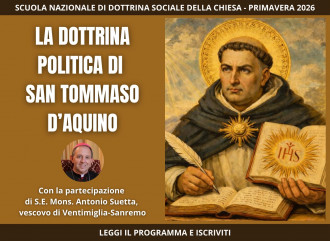Glifosate cancerogeno? E scatta la campagna contro i fitofarmaci
Ascolta la versione audio dell'articolo
Uno studio scientifico tutto da verificare mette sotto accusa il diserbante più usato dagli agricoltori, il glifosate. Ma subito monta una campagna mediatica che crea disinformazione sulla realtà dei fitofarmaci e dell'agricoltura.

Il glifosate, diserbante chimico usato in agricoltura, torna ad essere sul banco degli imputati e al centro di una bufera mediatica. Il motivo è la pubblicazione di un nuovo studio pubblicato su Environmental Health, secondo cui il glifosate sia più cancerogeno di quanto si credesse. Si tratta di uno studio tutto da verificare, ma intanto la notizia viene colta al volo per lanciare l'ennesima campagna contro l'agricoltura moderna a favore di quella bio. Per fare chiarezza, pubblichiamo di seguito un paper di Luigi Mariani, scritto in collaborazione con il professor Aldo Ferrero.
La maledizione della terra è fra le punizioni più terribili che Dio ha inflitto ad Adamo per aver mangiato il frutto che aveva comandato di non mangiare: “Ora, per colpa tua, la terra sarà maledetta: con fatica ne ricaverai il cibo tutti i giorni della tua vita. Essa produrrà spine e cardi….” (Genesi, 3, 17-18). “Spine e cardi” altro non sono che le malerbe, e cioè le piante selvatiche che competono con le colture agrarie per l’acqua, la luce e i nutrienti, riducendo a produzione delle colture in modo economicamente rilevante fino a rendere non conveniente la loro coltivazione.
Per risolvere un problema che era ed è esistenziale per molti agricoltori si sono, nel tempo, messi a punto svariati metodi di difesa, a iniziare dall’estirpazione manuale delle malerbe (si veda nel nuovo Testamento la parabola della zizzania), altresì indicata come scerbatura o monda. La monda è pratica massacrante e con pesanti ricadute sulla salute di chi la pratica e in proposito si pensi alle mondine che hanno operato nelle nostre risaie fino agli anni ’50 del ‘900. Per combattere le malerbe si sono poi utilizzati mezzi meccanici (zappe, sarchiatrici, ecc.) per giungere finalmente a mezzi chimici e cioè a sostanze in grado di uccidere le malerbe senza danneggiare la coltura. La chimica trova, infatti, vastissimo uso in agricoltura per combattere i nemici delle piante coltivate, non solo malerbe ma anche parassiti (insetti, acari, nematodi, ecc.) e patogeni (funghi, batteri, ecc.). I prodotti impiegati per proteggere le colture dai loro nemici sono chiamati agrofarmaci (medicine delle piante) anche se tende sempre più a diffondersi il termine “pesticida” derivante da una traduzione diretta dall’inglese pesticide, che indica genericamente una sostanza impiegata per combattere gli organismi dannosi alle colture. Tuttavia, in italiano, questo termine evoca inevitabilmente la “peste” in senso patologico o biblico, alimentando un immaginario negativo e infondato legato all’uso della chimica in agricoltura.
Questo pregiudizio linguistico e culturale contribuisce a diffondere una visione distorta, che rischia di oscurare un dato di fatto: l’agricoltura moderna, per essere produttiva e sostenibile, non può prescindere da un uso razionale della chimica. Basti pensare che senza i trattamenti fitosanitari, interi settori produttivi come quello viticolo sarebbero gravemente compromessi da malattie fungine endemiche (es. peronospora).
In prospettiva, sarà certamente possibile ridurre l’impiego di agrofarmaci grazie all’innovazione genetica e a tecniche agronomiche avanzate. Tuttavia, va riconosciuto che lo sviluppo e l’adozione di queste soluzioni incontra ancora forti resistenze ideologiche e normative, spesso non supportate da un’adeguata base scientifica.

Ma sono davvero così terribili i fitofarmaci?
Le autorità responsabili della salute pubblica usano per i fitofarmaci gli stessi criteri stabiliti per i farmaci usati in medicina umana. Sappiamo infatti che in natura tutto è veleno e i primi ad esserlo sono i farmaci, la cui efficacia a livello curativo si verifica fin tanto che le dosi sono quelle indicate dal medico. Il medico a sua volta stabilisce le dosi in base agli studi tossicologici che fissano le quantità massime eventualmente presenti come residui negli alimenti a valori inferiori 1/100 di quelle risultate innocue negli studi effettuati sugli animali.
Affinché i residui di fitofarmaci eventualmente presenti negli alimenti non risultino tossici, è fondamentale che in agricoltura vengano rigorosamente rispettate le norme di impiego, le quali stabiliscono dosi massime e tempi precisi di somministrazione.
Il rispetto di queste regole da parte degli agricoltori è confermato dai dati più recenti dell'EFSA (l'Autorità europea per la sicurezza alimentare) secondo i quali il 98% dei prodotti agricoli analizzati presenta residui al di sotto dei limiti di legge, e in tutti i casi i superamenti delle soglie non rappresentano un rischio concreto per la salute dei consumatori.
Il glifosate – i molti vantaggi che ne fanno il diserbante più utilizzato a livello mondiale
Il glifosate è un diserbante sistemico: una volta assorbito dalle foglie delle piante infestanti, viene traslocato attraverso la linfa fino a raggiungere anche le parti non direttamente trattate, come i fusti sotterranei (rizomi), contribuendo così a un’eliminazione completa della pianta.
È in commercio da oltre quarant’anni e il relativo brevetto, originariamente della Monsanto, è scaduto nel 2001. Da allora, numerose aziende ne producono versioni generiche, rendendo disponibili formulazioni efficaci a basso costo (circa 30 euro per diserbare un ettaro).
La tossicità acuta del glifosate è sorprendentemente bassa: risulta meno tossico dell’aspirina, del bicarbonato di sodio, del sale da cucina e della caffeina. È anche meno tossico di alcuni fitofarmaci autorizzati in agricoltura biologica, come il solfato di rame, l’azadiractina, lo spinosad e la nicotina.
Dal punto di vista ambientale, il glifosate ha un impatto contenuto: una volta applicato, si lega rapidamente alle particelle del suolo e si degrada in pochi giorni, senza accumularsi nelle acque o nei tessuti degli organismi. La sua eventuale presenza nei suoli e nelle acque non va confusa con un effetto nocivo, ma è semplicemente il riflesso della sua ampia e duratura applicazione a livello globale.
Il glifosate è oggi uno strumento fondamentale per l’agricoltura conservativa, un modello di coltivazione sostenibile basato sulla minima lavorazione del terreno e sulla semina diretta su sodo, una pratica fortemente sostenuta dalle autorità agricole e ambientali comunitarie. Questo approccio, che contribuisce a preservare la struttura del suolo, ridurre l’erosione e aumentare la fertilità, trova però il suo punto debole nella gestione delle infestanti: senza un diserbo efficace, risulta difficilmente praticabile.
Infine, va ricordato che l’eventuale proibizione del glifosate in Europa darebbe luogo ad un aumento dei costi di produzione con il rischio di un maggior impatto ambientale, in quanto gli agricoltori sarebbero costretti a ricorrere a diserbanti alternativi generalmente meno efficaci e più costosi, oltre ad essere, in alcuni casi, meno rispettosi dell’ambiente.
Il glifosate – i dubbi sulla cancerogenicità
Venendo ora alla presunta cancerogenicità del glifosate, occorre permettere che tutti noi abbiamo a che fare con sostanze tossiche e potenzialmente cancerogene, molte delle quali prodotte proprio dai vegetali che le sintetizzano naturalmente per difendersi dagli erbivori che se ne nutrono. Ciò non toglie che le verdure e la frutta siano fra i più importanti rimedi preventivi anticancro di cui disponiamo, per cui diffondere la psicosi dei residui di fitofarmaci induce una riduzione del loro consumo che non è favorevole a proteggerci dai tumori.
Lo Iarc (Agenzia internazionale di ricerca sul cancro) è un organismo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Il cui ruolo principale è quello di classificare gli agenti fisici, chimici e biologici in base al loro potenziale di causare il cancro negli esseri umani. In particolare Iarc colloca in classe 1 (sicuramente cancerogeni) svariate sostanze fra cui l’alcol etilico, il tabacco nelle sue varie forme di consumo, la radiazione solare ed in particolare la sua componente ultravioletta e le carni processate (salumi come pancette, salsicce, prosciutti, salami, speck, mortadelle ecc.). A un gradino più sotto nella classifica Iarc troviamo i prodotti probabilmente cancerogeni (classe 2A) e fra questi ricadono le carni rosse, le bevande con temperature superiori ai 65°C e per l’appunto il glifosate.
Da notare che lo Us National Toxicology Program (Ntp) pubblica anch’esso proprie liste di agenti cancerogeni suddivisi in “Noti come cancerogeni per l’uomo” e “Ragionevolmente prevedibili come cancerogeni per l’uomo”. E qui si noti che nelle liste di Ntp non figura il glifosate.
Ma come mai le autorità non proibiscono le bevande alcoliche o le carni rosse o ancora il glifosate o l’esposizione al sole? Anzitutto si deve dire che se un agente è noto o sospettato di causare il cancro ciò non significa necessariamente che possa o debba essere evitato a tutti i costi. Ad esempio, la luce solare è una delle principali fonti di raggi ultravioletti (UV), che sono una causa nota di cancro della pelle, ma non è per nulla consigliabile evitare l’esposizione al sole e in quanto la radiazione UV è essenziale per la produzione di vitamina D, vitale per la salute delle ossa, l'assorbimento del calcio e altre importanti funzioni corporee. Si noti inoltre che gli elenchi di Iarc includono molti farmaci di uso comune, alcuni dei quali sono ormoni e farmaci usati per trattare il cancro. Ad esempio, il tamoxifene aumenta il rischio di alcuni tipi di cancro uterino, ma può essere molto utile nel trattamento di alcuni tumori al seno, che possono essere più importanti per alcune donne.
Si aggiunga che lo Iarc nella sua lista parla di tossicità potenziale e dunque di pericolo, prescindendo dall’esposizione e dalla vulnerabilità, che sono essenziali per valutare in modo concreto il rischio di cancerogenicità.
Come previsto dalla normativa europea in materia di autorizzazione e revisione dei prodotti fitosanitari, il glifosate è stato sottoposto, a partire dal 2012, a due cicli completi di rivalutazione da parte delle principali autorità regolatorie europee e internazionali (Efsa, Echa, Iarc, Oms, Fao). Durante la prima revisione, nonostante il controverso inserimento del glifosate da parte dello Iarc nel gruppo 2A delle sostanze “probabilmente cancerogene per l’uomo” (lo stesso gruppo in cui sono inclusi il consumo di carne rossa o le bevande bollenti), la Commissione Europea ha deciso di rinnovarne l’autorizzazione fino al 15 dicembre 2022. A seguito di una seconda e più approfondita valutazione, condotta su oltre 2.400 nuovi studi scientifici – comprendenti sia letteratura indipendente che dati regolatori forniti dalle aziende – non sono emerse evidenze conclusive di effetti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione. Alla luce di questi risultati, la Commissione Europea ha rinnovato l'autorizzazione all’uso del glifosate fino al 15 dicembre 2033 (Reg. Ue 2660/2023).

Il più recente tentativo di demonizzazione del glyphosate
Sulla rivista scientifica Environmental Health è stato pubblicato recentemente uno studio a firma di Panzacchi e coautori dell’Istituto Ramazzini, in cui si segnala un aumento dell’incidenza di tumori benigni e maligni in ratti da laboratorio di entrambi i sessi in seguito all’esposizione cronica al glifosate, anche a dosi considerate sicure dai regolatori. Gli autori concludono che i loro risultati supporterebbero la classificazione proposta dallo Iarc, che ha inserito il glifosate nel gruppo 2A (“probabilmente cancerogeno per l’uomo”) sulla base di prove ritenute sufficienti di cancerogenicità negli animali da laboratorio.
Alla pubblicazione ha fatto seguito una diffusa risonanza mediatica, con articoli su quotidiani come Le Monde, The Guardian, l’Espresso, Il Manifesto e siti come Radio Lifegate e Slow Food, che hanno ripreso i risultati evidenziando i potenziali rischi per la salute umana. Parallelamente, la Commissione europea ha chiesto a Efsa ed Echa di rivalutare il dossier del glifosate alla luce del nuovo studio.
In questo contesto, i risultati di Panzacchi et al. suscitano sicuramente interesse, ma richiedono anche la necessaria cautela. Pur rappresentando un contributo al dibattito scientifico, essi si discostano in modo significativo dal corpus di evidenze finora esaminato dalle principali agenzie regolatorie, nazionali e internazionali. Va ricordato, infatti, che il glifosate è stato oggetto di due ampi cicli di revisione scientifica e normativa dal 2012 a oggi, culminati con la decisione della Commissione europea di rinnovarne l’autorizzazione all’impiego fino al 2033.
In una dettagliata analisi critica pubblicata su Il Foglio il 9 luglio scorso, i ricercatori Angelo Moretto e Roberto Defez hanno evidenziato alcune incongruenze nei dati sperimentali presentati da Panzacchi e colleghi. In particolare, nei gruppi trattati con glifosate, puro o formulato, sarebbero emersi risultati paradossali, con una riduzione significativa dell'incidenza di alcuni tipi di tumore (surrenali, meningi, utero, timo) rispetto ai gruppi di controllo, tanto da rendere il numero complessivo di tumori sostanzialmente simile o addirittura inferiore nei ratti esposti al glifosate rispetto a quelli non trattati. Moretto e Defez accusano inoltre gli autori di avere enfatizzato selettivamente solo i dati che indicano un potenziale aumento dell’incidenza tumorale, trascurando quelli che mostrano effetti neutri o addirittura protettivi, e facendo ricorso ad artifici statistici poco trasparenti.
È quindi fondamentale che questi risultati vengano sottoposti a una valutazione rigorosa da parte della comunità scientifica indipendente, anche alla luce di aspetti metodologici che restano da chiarire, come la scelta del modello animale, la significatività statistica dei dati, e la loro traslazione al contesto umano.
Prima di essere ritenuti meritevoli di considerazione in un eventuale processo di revisione normativa, tali risultati devono essere confermati, discussi e integrati nel più ampio contesto della letteratura scientifica disponibile. Come stabilito dalle prassi consolidate in ambito regolatorio, infatti, una singola pubblicazione – ancorché potenzialmente rilevante – non può da sola costituire una base sufficiente per modificare un profilo tossicologico consolidato, senza un’analisi comparativa approfondita e una validazione da parte di più fonti indipendenti.
Quale morale
Non vorremmo, dunque, che in un’Europa sempre più segnata da isterismi collettivi e pulsioni chemofobiche, un singolo studio – per quanto meritevole di attenzione ma ancora lontano dall’essere pienamente validato – potesse innescare decisioni affrettate e sproporzionate. Sarebbe paradossale assistere all’esclusione del glifosate, molecola ampiamente studiata e tuttora considerata sicura dai principali organismi regolatori, dalla già esigua panoplia di strumenti fitosanitari a disposizione degli agricoltori. Ma, come insegna la saggezza popolare: quando Dio vuole perdere un popolo, prima gli toglie la ragione.
*Aldo Ferrero, docente di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) presso l'Università di Torino