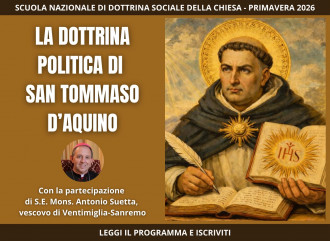Brucia l’origine, quando il ritorno non salva
Nell’ultimo romanzo di Daniele Mencarelli, Brucia l’origine, il ritorno a casa è vissuto dal protagonista come una resa dei conti. Scopre che il tempo non ha cambiato nulla, mentre lui è cambiato troppo. È diventato ricco e famoso, ma non felice…

La vita dell’uomo è fatta di partenze. Di treni presi all’alba, di strade lasciate alle spalle, di sogni consumati nel viaggio. Ma il ritorno — quel ritorno che promette salvezza — spesso non arriva. O peggio, arriva troppo tardi. Il nonno dei Malavoglia lo sa: desidera tornare alla casa del nespolo, morire dove ha vissuto, tra le mura che hanno custodito la sua esistenza. Ma quando il carro arriva, lui è già partito per quel viaggio «più lontano di Trieste e d’Alessandria d’Egitto», da cui non si torna. E il silenzio cala, come una coperta sul dolore. Da quel momento, ogni volta che si parla di lui, i nipoti tacciono. Il lutto non è solo morte: è perdita di senso.
Il giovane ’Ntoni, invece, torna davvero. Ma non è più lui. Il cane abbaia, la casa non lo riconosce, la minestra è fredda. Mangia in silenzio, mentre gli altri non hanno fame. Il tempo ha fatto il suo lavoro: ha cancellato i volti, ha svuotato le stanze. E quando si alza per andarsene, capiamo che il ritorno non è salvezza, ma esclusione. «Ora che so ogni cosa, devo andarmene» dice. E il mare gli brontola la solita storia. La nostalgia non salva, non consola. È solo il suono di ciò che non può più essere.
Anche Anguilla, in La luna e i falò, torna al paese. Ma non trova che assenza. I compagni sono morti, le radici recise. «Un paese ci vuole», scrive Pavese, «non fosse che per il gusto di andarsene via». Il ritorno è malinconia, è consapevolezza. È maturità. Ripeness is all, scrive Shakespeare: la maturità è tutto. E la maturità è sapere che non si torna davvero, che il passato è un luogo che non ci appartiene più.
Il fuoco come possibilità
E allora, cosa resta? Resta il fuoco. Resta il bruciare dell’origine. Ed è qui che entra Daniele Mencarelli, voce contemporanea di un dolore antico. Nei suoi romanzi, il ritorno non è mai possibile. La casa è ferita, il padre è assenza o silenzio, la memoria è cenere. Ma nel fuoco, forse, si può rinascere. Non si torna: si attraversa. E nel viaggio, si scopre che la salvezza non è nel luogo, ma nello sguardo dell’altro. È lì che Mencarelli ci conduce: nel cuore bruciante dell’origine, dove la parola diventa rivelazione, e la poesia, finalmente, verità.
Gabriele Bilancini: il ritorno come resa dei conti
Protagonista di Brucia l’origine, Gabriele Bilancini ha fatto tutto ciò che si suppone debba fare chi vuole «farcela» — come Anguilla, che ha lasciato le Langhe per l’America. Ha seguito il fuoco che fin da piccolo ha nel cuore, ha colto la prima occasione che la realtà gli ha offerto ed è divenuto un designer di successo. Ha lasciato il quartiere popolare di Roma, ha inseguito il talento, ha trovato il successo a Milano, ha conquistato l’amore e l’approvazione dei potenti. È diventato un nome, un marchio, una promessa realizzata. Ma nulla è perfetto: una foto messa in circolazione fa pensare a tutti che la sua ascesa e notorietà sia stata permessa da una relazione con il proprietario dell’azienda, tra l’altro padre della sua fidanzata.
Ma quando torna a casa, dopo alcuni anni, scopre che il tempo non ha cambiato nulla. E che lui, invece, è cambiato troppo. La casa è identica, gli amici sono lì: Marcello, Cristiano, Vanessa, Francesco. Sono rimasti fermi, come se la vita non avesse riservato per loro alcuna possibilità di ascesa. Il bar del sor Antonio è ancora il punto di ritrovo. Ma l’abbraccio del passato è dolce e soffocante. Gabriele si vergogna delle sue origini, le nasconde come si nasconde un peccato. Eppure, quel quartiere lo ha nutrito, lo ha formato, lo ha amato. Proprio lì ha conosciuto il suo primo amore e il sesso.
Gli amici lo considerano fortunato: ha successo, guadagna cifre importanti, appartiene ora al mondo dei ricchi milanesi. Immersi da sempre nella povertà, vivono l’illusione che chi ottiene il successo raggiunga finalmente la pienezza della vita. Ma a Milano, Gabriele ha fatto un’amara scoperta: i soldi non bastano. Le domande che bruciano restano tutte nel cuore. L’illusione degli amici, che un tempo era anche sua, rivela tutta la sua inconsistenza.
Gabriele prova a rivelarlo agli amici, che non accettano le sue delusioni. Con Cristiano, il più provocatore, avviene il chiarimento: «Vivo senza una terra, senza un mondo, me sento sospeso, ovunque». Ha finalmente avuto il coraggio di riconoscerlo a se stesso. Cristiano gli replica: «Noi te facevamo ricco e felice. Ricco ce sei diventato, mortacci tua, ma sul felice, ce devi ancora lavorare».
Identità, classe, appartenenza
Ora quel quartiere lo stringe, lo interroga, lo costringe a guardarsi dentro. Il ritorno non è festa: è resa dei conti. Lì, lui ride, come non rideva più da anni. Come ’Ntoni, come Anguilla, anche Gabriele scopre che non si torna davvero. Si può ritornare fisicamente, ma l’anima resta sospesa: non si è più parte del vecchio mondo, ma non si appartiene nemmeno al nuovo. Si è stranieri ovunque. E allora, cosa resta? Resta la frattura. Resta il fuoco.
Mencarelli racconta tutto questo con una lingua che ci immerge nel mondo della Roma di periferia, con regressioni che ci portano in classi sociali più basse rispetto a quelle frequentate dal protagonista — e forse anche rispetto al lettore. Brucia l’origine ha un sapore politico e intimo: parla di classi sociali, di vergogna, di appartenenza, ma anche di amore, di amicizia, di identità.
Gabriele non cerca di tornare: cerca di capire. E nel farlo, ci costringe a guardare anche noi la nostra origine, a interrogarla, a smettere di nasconderla. Forse, come ci hanno narrato Verga e Pavese, il ritorno non è salvezza. Ma nel fuoco, se si ha il coraggio di restare, può nascere qualcosa di nuovo.
Il presente come luogo dell’eterno
Non ci sono risposte preconfezionate nella vita, né ideologie salvifiche. Ogni uomo ha una vita da vivere, al presente, troppo urgente per restare attaccato al passato. Puoi provare a fermarlo, il passato, ma invano, come Gabriele che cerca di abbracciare gli acquedotti, che agli occhi della sua fantasia appaiono come elefanti. «Elefanti che la sera, da bambino, immaginava di ritorno verso la loro casa». Ora «gli acquedotti, gli elefanti, se ne stanno andando», come mostra la bella immagine di copertina.
È nel presente che si vive l’amore, direbbe il Lewis de Le lettere di Berlicche. Nel presente si fa esperienza della profondità dell’eterno. Il presente di Gabriele è il nostro: fragile, bruciante, vero.