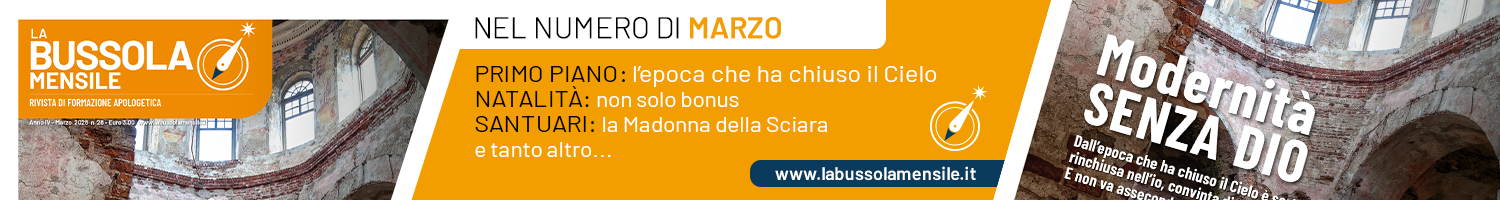Trump a Davos, la guerra dei mondi entra nel vivo
Ascolta la versione audio dell'articolo
L'intervento del presidente americano al Forum di Davos permette di fare il punto sulla reale agenda degli Usa: il mito della governance globale e del multilateralismo ideologico portato avanti dall’iniziativa del Great Reset di Davos e dall’Onu viene archiviato. Non solo, viene messo in discussione tutto l’“ordine” globale degli ultimi 80 anni, dall’ordine monetario-finanziario ridisegnato nel 1971 agli equilibri geopolitici. Ritornano le nazioni e l’economia reale. Il mondo si sta ridisegnando in sfere di influenze sotto ai nostri occhi. E l’Europa resta a guardare.
- E alla fine si arrivò all'accordo sulla Groenlandia, di Gianandrea Gaiani

Veni. Vidi. Vici. Potremmo sintetizzare in questi termini lo spirito con cui il presidente Trump si è recato a Davos all’incontro annuale del World Economic Forum, l’organizzazione pubblica-privata che persegue dal 1971 l’obiettivo di creare “un mondo migliore”. Il tanto atteso discorso di Trump, a braccio e un po’ raffazzonato, non ha affrontato in modo diretto quel mondo globalista e liberal che a Davos ha il proprio quartier generale, che lo ha sempre osteggiato e che ora deve fare buon viso a cattiva sorte. Evidentemente gli “incontri-scontri” veri e propri avvengono a porte chiuse, e difficilmente ne avremo resoconti ufficiali.
Nel suo discorso fortemente auto-elogiativo Trump si è limitato a fare l’apologia, assai stucchevole, degli straordinari risultati sul versante economico e della pacificazione globale che avrebbe ottenuto la sua amministrazione nei primi 12 mesi, ribaltando l’eredità e l’immagine del Paese al collasso lasciato da “sleepy” Joe Biden. Per capire dove si vuole andare a parare non dobbiamo però limitarci ad analizzare le parole del presidente guascone: collegando i puntini delle cose dette e non dette, e soprattutto delle cose fatte e non fatte nei mesi passati, emerge un quadro abbastanza chiaro della strategia perseguita.
Sul piano geopolitico, gli Stati Uniti hanno definitivamente abbandonato ogni velleità di esportare il modello liberal-democratico nel resto del mondo per concentrarsi sui propri gravi problemi interni: dall’immigrazione incontrollata alla devastazione del fentanyl, dalla deindustrializzazione al collasso della classe media, dalla polarizzazione della società al tramonto del sogno americano, dalla crisi finanziaria con una traiettoria del debito fuori controllo alle minacce di de-dollarizzazione che potrebbero spodestare il Re dollaro e mettere in discussione il ruolo di leadership statunitense.
La crescita economica diventa l’elemento critico per la stabilità finanziaria: con un debito federale superiore ai 38mila miliardi di dollari, in crescita di circa 500 miliardi al trimestre, il rischio di “bancarotta” non è infatti mai stato così elevato. Per evitarlo gli Usa devono crescere e reindustrializzarsi aumentando le fonti di energia, deregolamentando e attirando investimenti diretti, oltre a garantirsi acquisti dall’estero di armamenti, gas naturale e Treasury, tagliare le spese improduttive e migliorare gli squilibri commerciali, preservare il ruolo del dollaro come divisa di riserva globale.
Una mission impossible, nascosta sotto il quadro, troppo bello per essere vero, delle “magnifiche sorti e progressive” degli Usa rappresentato da Trump. Il suo obiettivo, perseguito con eccessivo zelo, è quello di convincere i suoi interlocutori che gli Usa sono il Paese più prospero e forte al mondo, quello dove si possono fare gli affari migliori. La realtà, assai più prosaica, spiega sia la retorica di Trump sia la sua aggressività, portata alla sfrontatezza, per raggiungere, a qualsiasi costo, gli obiettivi che si è prefisso. D’altronde lo aveva annunciato chiaramente in campagna elettorale: Make America Great Again è lo slogan-mandato per cui è stato eletto, e bisogna dargli atto che sta perseguendo l’obiettivo in modo diretto e senza infingimenti. Occorre poi ricordare che Trump è al suo secondo e quindi, almeno in teoria, ultimo mandato: non ha nulla da perdere, non gli interessa più di tanto il consenso e mira piuttosto a ritagliarsi un posto nei libri di storia. Peccato che i leader europei non pensino anch’essi a mettere in primo piano lo sviluppo e il benessere dei propri popoli.
Non c’è tempo, quindi, per la diplomazia, occorre invertire la tendenza subito, costi quel che costi. Una necessità che spiega perché gli Usa non possono più permettersi di trainare l’Europa e la Nato, soprattutto alla luce della necessità urgente di riposizionarsi sul Pacifico, nuovo vero centro del mondo, su cui si affacciano insieme la Federazione Russa, la Cina, l’India e il Giappone, non a caso indicati come il nuovo “C5” che dovrebbe sostituire l’obsoleto G7. Un nuovo ordine in cui non c‘è molto spazio per l’Unione Europea, per il Regno Unito e per il Canada.
Nel costituendo “Board of Peace” per la ricostruzione di Gaza, Trump mira a creare una sorta di piccola Onu alternativa, da lui controllata, a cui far partecipare le grandi potenze sopra indicate oltre a Paesi considerati in qualche modo “allineati” o “allineabili” con gli interessi statunitensi, dalla Bielorussia alla Turchia, dall’Argentina all’Italia (in forse), da Israele ai Paesi arabi.
Non è quindi presente il “soggetto” Europa, che Trump non ha mai riconosciuto. La Francia di Macron, presa pubblicamente in giro, non ha accettato l’invito, la Germania di Merz non intende partecipare, mentre il Regno Unito parteciperà con Tony Blair anziché col premier Starmer. Per accedere al Board ciascun Paese dovrà apportare 1 miliardo di dollari in dotazione, ed è probabile che il costituendo club non si occuperà solo della ricostruzione di Gaza e della stabilizzazione del Medio Oriente ma anche della composizione degli interessi delle grandi potenze, con sfere di influenza e rapporti bilaterali ancora in fase di definizione.
Trump “resetta” il Great Reset: non c’è tempo per la decrescita felice, per l’ideologia climatista – il Green New Scam come lo chiama lui –, per i vaneggiamenti woke. L’imperativo è crescere, per preservare la pace sociale interna e rendere il Paese più forte anche sul piano della difesa. E per crescere serve energia, da cui la scelta di aumentare la produzione di idrocarburi e di accelerare sul nucleare di ultima generazione.
In questa prospettiva si comprende anche l’uscita degli Usa da 66 organizzazioni internazionali, molte di queste appartenenti all’Onu, sia per risparmiare denaro dei contribuenti statunitensi sia per sottrarsi al controllo di organismi poco trasparenti con agende non allineate con le priorità dell’amministrazione.
Per la prima volta dalla guerra di Indipendenza gli Usa prendono le distanze dallo stesso ex-alleato di ferro, il Regno Unito. Il ritorno a una visione industriale presuppone anche il contrasto alla finanziarizzazione dell’economia la cui testa è nella City di Londra, insieme a Wall Street. La priorità diventa main Street: il passaggio dalla “carta” ai metalli preziosi, con i fortissimi apprezzamenti di oro, argento e platino degli ultimi mesi, è un segnale di “ritorno al reale” e di rottura di equilibri monetari-finanziari consolidati a partire dalla fine del Gold-exchange standard nel lontano 1971.
In questa prospettiva si comprendono meglio anche gli affondi impietosi contro il presidente della Fed, ridenominato Jerome “late” Powell, a causa della sua pretesa lentezza nell’abbassare i tassi di interesse. Al di là dei modi davvero offensivi, inutile lamentare, come fanno molti, l’attacco di Trump alla presupposta “indipendenza” della Fed: la Banca centrale statunitense non è mai stata indipendente, è stata fondata nel 1913 come parte integrante del cartello bancario-finanziario, al servizio dei grandi gruppi e di Wall Street. La sistematica distruzione di potere d’acquisto del dollaro, perseguita con politiche monetarie ultra-espansive, è la prova che la Fed ha sistematicamente tradito il suo mandato di preservare la stabilità monetaria-finanziaria. Si spera che la direzione che prenderà la nuova Fed, probabilmente portata sotto un controllo di fatto del Tesoro, sia maggiormente rispettosa dell’etica della produzione della moneta. Ma non c'è da scommetterci. È auspicabile che inizi anche un forte contrasto al capitalismo clientelare, che affonda le proprie radici in quello “Stato profondo” – di cui basti citare la CIA e il complesso militare-industriale –, che spera in un azzoppamento di Trump nelle elezioni di metà mandato di novembre 2026 per riprendere l’agenda Clinton-Obama-Biden, di conserva con i globalisti arroccati al WEF e nelle cancellerie europee.
Una precisazione, a scanso di equivoci: il fatto che l’ordine globalista esistente meriti di essere distrutto non significa che tutti i mezzi e le scelte di Trump siano condivisibili. Neppure ci si può illudere che i risultati raggiunti siano sicuramente positivi. Giunti allo stato in cui ci troviamo, in particolare in Europa, non sono però possibili pannicelli caldi e cure omeopatiche: i nodi gordiani vanno tagliati con la spada, anche perché non c’è più tempo. A partire dai rischi di escalation militare nel confronto tra l’Europa e la Federazione Russa e in Medio Oriente, dove Israele continua a perseguire il miraggio della “soluzione finale” contro l’Iran.
Il “metodo Trump” crea confusione, senza dubbio, e non è esente da critiche; non si può dire, tuttavia, che abbia provocato grossi danni, almeno fino ad oggi. Più che a quello che dice è meglio guardare a quello che fa: se riuscirà a smantellare l’agenda globalista, liberal e woke del World Economic Forum di Davos, avrà già meritato la nostra riconoscenza. Se la fase “bonapartista” in atto venisse sconfessata dalle elezioni di midterm possiamo invece attenderci un rilancio dell’iniziativa del Great Reset in tutto il mondo occidentale. Il Regno Unito di Starmer, il Canada di Mark Carney, la Francia di Macron, la Germania di Merz e la Commissione Europea ripongono le proprie speranze proprio in un azzoppamento di Trump a novembre. Nel frattempo fanno melina e proseguono i propri piani di controllo sociale con la repressione del dissenso interno grazie al Digital Services Act e con i progetti di digitalizzazione dell’identità e del denaro. Non arretrano, poi, con le politiche suicide di transizione energetica e di keynesismo militare, col rischio di portare l’Europa, oltre all’irrilevanza geopolitica, anche al collasso economico-sociale come potrebbe accadere in Germania in tempi non lontani.
Se gli Stati Uniti riusciranno a far collassare questa agenda è un bene: piaccia, o non piaccia, Donald Trump. La guerra dei mondi sta entrando nel vivo: l’Italia e l’Europa farebbero bene a smettere di seguire il pifferaio di Davos e a riflettere su come posizionarsi.
Maurizio Milano è autore di Il pifferaio di Davos: Il Great Reset del capitalismo: protagonisti, programmi e obiettivi - Il Nuovo (dis-) Ordine Mondiale: dal globalismo ideologico al multipolarismo caotico, D’Ettoris Editori, 2025.
Schwab o Lagarde, a Davos la musica non cambia: è sempre Grande Reset
Klaus Schwab, ex-Presidente del World Economic Forum di Davos, rivela trattative con Christine Lagarde, presidente della Bce: vuole chiudere il suo mandato per presiedere il Wef. Giri di poltrone in un circolo ristretto della finanza.
Il pifferaio di Davos, ovvero: gli obiettivi del Great Reset
Dalle origini del Forum di Davos al ruolo (da frontman) di Klaus Schwab, fino al Covid sfruttato per far avanzare il piano del Great Reset. Le ricadute disastrose su tanti campi: auto e case incluse. Il videoincontro della Bussola con l’economista Maurizio Milano.