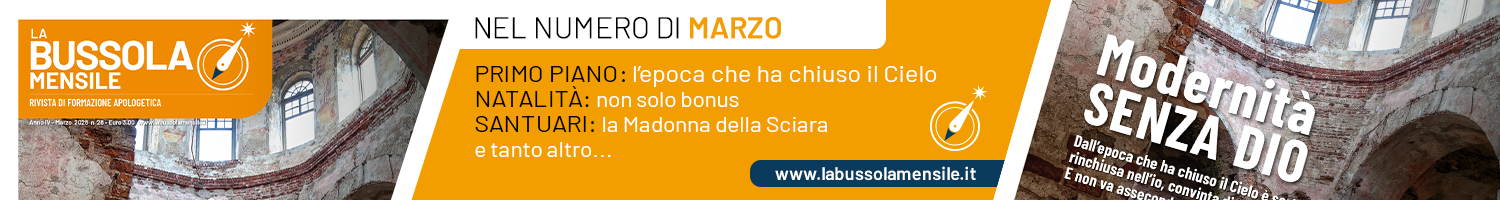Premi Pulitzer dati a due scandali più che ai giornalisti
Nato grazie alla donazione di József Pulitzer, editore di stampa scandalistica, il premio Pulitzer è ora considerato l'equivalente del Nobel per i giornalisti. Ma l'attuale edizione del premio non smentisce le sue origini: infatti sono stati premiati due scandali, il caso Weinstein e il Russiagate.

Non occorre esserne un fan per appezzarne lo humor, l’ironia e le perline in forma di boutade che Umberto Eco (1932-2016) ha disseminato nel mare del suo pensiero neo-nominalista. Diceva per esempio che, per nascondere qualcosa, basta metterla in evidenza. Ieri è stato assegnato il Premio Pulitzer 2018 e nessuno sa da dove venga davvero anche sta scritto pure su Wikipedia.
Il Pulitzer è un po’ il Nobel del giornalismo, delle composizioni letterarie e di quelle musicali. Fu istituito nel 1917 in onore di József (poi Joseph) Pulitzer (1847-1911), statunitense di origine ungherese, editore dei quotidiani St. Louis Post Dispatch (esce ancora) e New York World (non esce più), che con un lascito favoloso finanziò una scuola di giornalismo alla Columbia University di New York. Prima che per il Premio, Pulitzer è però famoso per un’altra invenzione. La stampa ciarlatana delle fake news. In inglese suona yellow journalism. Negli anni 1890 andò in scena una lotta di tirature senza quartiere fra il New York World di Pulitzer e il New York Journal di William Randolph Hearst Sr. (1863-1951), due imprenditori, due editori, due uomini politici. Fu un duello tutto interno alla Sinistra americana: Pulitzer era stato Repubblicano quando i Repubblicani erano progressisti per poi farsi Democratico quando i Democratici cercarono di far dimenticare di essere stati reazionari; Hearst era l’ala estrema del Progressivism, un positivismo neoilluminista, eugenista e monopolista che curiosamente tutti denunciano come “capitalismo di destra” e che invece sacrificò la proprietà privata diffusa sull’altare delle concentrazioni consociativiste. Ebbene, per alzare le vendite i due trasformarono i giornali in puro trash tutto sensazionalismo, titoli urlati, balle colossali e poi giochi e fumetti, allora popolarissimi. Tra il 1895 e il 1898 pubblicarono entrambi le strisce di Hogan’s Alley disegnate da Richard F. Outcault (1863-1928) con protagonista The Yellow Kid, alias Mickey Dugan, un bimbetto rasato contro le lendini, denti malandati, orecchie a sventola e camicia da notte gialla fino ai piedi nudi ereditata da una sorella più grande che si aggirava per gli squallori della Grande Mela visti in Gangs of New York. Il “giornalismo giallo”. Niente obiettività, esagerazioni, speculazioni, zero professionalità: questo fu Pulitzer, e oggi la stampa se ne fregia.
Quest’anno l’“autorevole” Pulitzer ha premiato, tra diversi altri, l’“eccellenza” musicale del rapper Kendrick Lamar (yeah, c’mon, wow), poi The New York Times e The New Yorker nella sezione “public service” per avere scovato il “caso Weinstein”, nonché The Washington Post (quello di Jeff Bezos, padrone di Amazon) e di nuovo The New York Times nella sezione “national reporting” per avere snudato il “Russiagate”. Ci sono stati altri premiati, ma praticamente si parla solo di questi. Le sporcaccionate di Harvey Weinstein hanno sturato la botte Hollywood e n’è uscito più che dal vaso di Pandora. Tanto di cappello. Ma una domanda: se tutti sapevano perché dirlo solo ora che la carriera pagata da molti a quel caro prezzo è ben avviata e forse Weinstein meno potente di prima? Quanto al “Russiagate”, sembra un film di fantascienza dove mediante un marchingegno alieno rispunti dall’altra parte del cosmo fra gli extraterrestri. Giorni fa, il notiziario delle 8,00 di Radio 24, quella della Confindustria, sparava così: titolo, Russiagate; svolgimento: l’FBI perquisisce gli uffici di Michael D. Cohen, avvocato personale di Donald J. Trump, per provare i pagamenti del presidente a Stormy Daniels. Purtroppo il giallo alla radio non si vede. Cosa lega le presunte collusioni da alto tradimento fra Trump e Cremlino al sesso adultero?
“Stormy Daniels” è nata Stephanie A. Gregory Clifford a Baton Rouge, in Louisiana, nel 1979. Fa la pornoattrice (perché bisogna chiamarle pornostar, stelle di cosa?). Dice infatti di avere fatto sesso con Trump una sola volta nel luglio 2006. Lo dice in una intervista vecchia del 2011 pagata 15mila che salta fuori solo adesso perché Trump l’avrebbe bloccata, pure minacciando “Stormy”, e i cui contenuti salienti l’attrice ha ripetuto in televisione a fine marzo. Dice poi che 11 giorni prima delle elezioni dell’8 novembre 2016 l’avvocato Cohen le ha proposto di non divulgare la storia, offrendole 130mila dollari per blindare il patto omertoso. Scritto. E da lei firmato. Il 13 febbraio Cohen ha però poi ammesso di averla pagata, di tasca propria, senza rimborsi di Trump. Quindi, avendo Cohen violato il patto, “Stormy” si sente libera di vuotare il sacco. Ma se Cohen ha pagato per Trump e Trump non lo ha rimborsato, perché Cohen non denuncia Trump? Dunque i soldi (di Cohen) la Daniels li ha presi. E quindi ora parla solo perché Cohen ha parlato prima, tenendosi i soldi? Perché non tacere e negare tutto, visto che, tra l’altro, la Daniels dice che l’accordo omertoso e danaroso lo ha firmato pure per preservare la figlia di sette anni dalla brutta notizia? (I 152 film porno che ha girato e i 44 di cui è regista invece fan niente?)
Su tutto e prima di tutto sta comunque un altro punto. Se l’uomo sposato Trump è andato con una pornoattrice 12 anni fa è una cosa brutta. Ma che c’entra il presidente? Qualcuno ha mai fatto il contropelo a John F. Kennedy (1917-1963) perché non si lasciava scappare una gonna nemmeno alla Casa Bianca? Lo scandalo Monica Lewinksy non fu voyeurismo: fu che il presidente in carica del Paese più importante del mondo ebbe rapporti sessuali nella Casa Banca giurando di non averlo mai fatto. Credibilità, non sesso.
Epperò se Trump ha fatto quel che “Stormy” dice non dovrebbe essere un eroe del mondo di oggi, quello dell’amore libero, della poliaffettività, del faccio-quel-che-voglio, del vietato vietare, del non esistono perversioni, del tutto è lecito, del basta-che-siano-adulti-consenzienti? In effetti pare che per il mondo l’unico problema sia se la Daniels abbia preso i 130mila dollari di Cohen da parte di Trump 11 giorni prima delle elezioni, cosa che, avendo ciò aiutato la campagna elettorale di Trump, equivarrebbe a un finanziamento di Cohen a Trump oltre quanto consentito dalla legge. Per chi invece non appartiene a quel mondo pur vivendoci, Trump non è al “giornalismo giallo” e alla mandria mugghiante che deve rispondere, ma a se stesso, alla moglie, ai figli e a Dio. Giriamo pagina.
Insomma, “Stormy” non c’entra nulla con il “film di fantascienza” grazie al quale The Washington Post e The New York Times hanno vinto il Pulitzer, quel “Russiagate” che più volte su queste colonne è stato raccontato come un nulla di fatto. Arresti di ex collaboratori già dimissionati da Trump che con le presunte collusioni moscovite non c’entrano, nessuna prova d’illeciti e soprattutto quali illeciti. L’unica ingerenza dimostrata dei russi nella politica americana è lo scompiglio creato dalle troll factory per tentare di cortocircuitare il proprio avversario più grosso.
Restiamo in area. Oggi l’ex direttore dell’FBI James B. Comey strilla dalle pagine del suo libro, A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership (Macmillan). Possibile che l’uomo pagato 185mila dollari l’anno per dirigere la corrazzata di polizia con il pelo sullo stomaco più lungo del mondo, l’FBI, l’uomo che è stato seduto sulla poltrona che fu di J. Edgar Hoover (1895-1972), olimpionico di lunghezza pilifera, non sia stato capace di tenere testa a un tycoon più ricco di fallimenti finanziari che altro facendosi licenziare per poi ricorrere al botteghino? È o non è deep questo deep state?
Noi che, grazie a Dio, il Premio Pulitzer nemmeno sa che esistiamo cambieremo volentieri opinione solo se e quando il “Russiagate” dov’esse rivelarsi vero. Nei fatti, non nel gossip dello yellow journalism cui preferiamo i gialli veri: tipo quello del clan Clinton, scritto anche da Comey, dall’allora ministro della Giustizia Loretta Lynch e forse anche da Barack Obama, dimostrato con prove, ma che nessun premio però si fila.