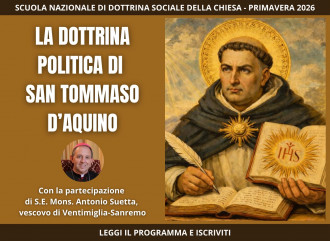Piano antismog, lo strappo delle regioni "amiche"
Ascolta la versione audio dell'articolo
Lombardia, Piemonte e Veneto impugnano davanti alla Corte Costituzionale il “Piano nazionale per il miglioramento della qualità dell’aria” emanato dal Governo dopo la procedura di infrazione Ue. Costi alti a carico delle regioni e nessuna compartecipazione statale.

Lombardia, Piemonte e Veneto hanno deciso di fare fronte comune e di impugnare davanti alla Corte Costituzionale il “Piano nazionale per il miglioramento della qualità dell’aria”, approvato dal Consiglio dei ministri il 20 giugno e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 agosto. Le tre Regioni del Nord, tra le più virtuose nella gestione ambientale, contestano apertamente l’impostazione del piano governativo, accusando lo Stato centrale di accentrare competenze senza assumersi le relative responsabilità economiche.
Si tratta di una vera e propria rivolta istituzionale che chiama in causa la legittimità del provvedimento, l'equilibrio dei poteri tra centro e periferia, ma anche il modello di gestione della transizione ecologica nel Paese. Il cuore del contendere è la previsione che l’onere delle misure antismog ricada “in via ordinaria” sulle Regioni, mentre allo Stato spetti un ruolo solo “in via complementare”. In pratica, secondo l’attuale assetto del Piano, le Regioni dovrebbero farsi carico di attuare le misure per la riduzione delle emissioni inquinanti, come se fossero le uniche responsabili della qualità dell’aria, senza però che venga previsto alcun aumento dei fondi a loro disposizione. Un’impostazione che i governatori del Nord considerano inaccettabile, anche alla luce del fatto che la tutela dell’ambiente è, secondo la Costituzione, materia di competenza esclusiva statale.
Dunque, oltre a una questione economica, siamo davanti a una questione giuridica e politica di prima grandezza, che potrebbe segnare un nuovo passaggio nel già delicato rapporto tra autonomie regionali e poteri centrali, confermando la spiccata attitudine centralista dell’attuale esecutivo.
Il Piano anti-smog nasce come risposta a una doppia procedura d’infrazione avviata dalla Commissione Europea contro l’Italia. La prima risale al 2020, con una sentenza della Corte di giustizia europea che condannava il nostro Paese per il mancato rispetto dei limiti di emissione di particolato sottile (PM10) e ossidi di azoto (NOx), soprattutto nella Pianura Padana, uno dei bacini più inquinati d’Europa. Da allora, secondo Bruxelles, l’Italia ha fatto poco o nulla per adeguarsi. Così, nel 2024 è stata aperta una nuova procedura d’infrazione, con obiettivi stringenti da raggiungere entro tre anni.
Le misure richieste dall’Unione Europea sono numerose e complesse: riduzione delle emissioni in agricoltura con l’uso di fertilizzanti a basso impatto emissivo, adozione di tecniche di allevamento sostenibili, efficientamento energetico degli impianti di riscaldamento civile, sviluppo della mobilità sostenibile attraverso il potenziamento del trasporto pubblico locale e delle forme di mobilità condivisa, oltre ad azioni di informazione e sensibilizzazione dei cittadini per promuovere comportamenti virtuosi. Un piano articolato, che richiede investimenti considerevoli e azioni coordinate su più livelli istituzionali. Eppure, il Governo ha deciso di trasferire quasi interamente l’attuazione di queste misure sulle Regioni, che già affrontano da sole gran parte delle emergenze ambientali, senza però prevedere uno stanziamento straordinario di risorse.
Da qui il ricorso alla Corte Costituzionale da parte delle tre Regioni del Nord, che denunciano un atteggiamento centralista e scaricabarile da parte dell’Esecutivo. «Non è un atto contro il governo Meloni» hanno precisato i presidenti Attilio Fontana (Lombardia), Alberto Cirio (Piemonte) e Luca Zaia (Veneto), «ma un richiamo al rispetto dei ruoli istituzionali e alla necessità di un’effettiva leale collaborazione tra Stato e Regioni». Il punto è chiaro: le Regioni non possono fare le nozze con i fichi secchi. Non si può pretendere che si realizzino interventi strutturali, costosi e complessi, senza mettere a disposizione i fondi necessari.
È una battaglia per l’equità istituzionale, ma anche per una transizione ecologica che sia sostenibile non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico e amministrativo. Emblematica è la posizione della Lombardia, che rivendica a gran voce i risultati raggiunti negli ultimi due decenni: un calo del 40% delle emissioni inquinanti, una significativa riduzione dei giorni di sforamento dei limiti di PM10 e una serie di iniziative concrete per il rinnovo del parco veicolare privato e aziendale.
Proprio in questi mesi è attiva la seconda fase del bando regionale per la rottamazione dei veicoli più inquinanti e la loro sostituzione con mezzi a basse o zero emissioni: la prima fase ha raccolto oltre 4.000 domande in soli due mesi, con 23 milioni di euro stanziati. La Linea A del bando incentiva la sostituzione di veicoli inquinanti con auto ecologiche, la Linea C finanzia la semplice rottamazione, mentre la Linea B – già chiusa per esaurimento fondi – aveva sostenuto l’acquisto di ciclomotori elettrici ed eCargo Bike. Segno di una partecipazione diffusa dei cittadini lombardi, che dimostra quanto la sensibilità ambientale sia già radicata nei territori.
Un altro esempio viene dalla gestione delle pratiche agricole, dove già oggi si sperimentano tecniche innovative a basso impatto, e dalla promozione del trasporto pubblico locale, con investimenti nella mobilità elettrica e nella digitalizzazione dei servizi. Nonostante ciò, la Regione si vede ora costretta ad affrontare un piano nazionale che rischia di disincentivare proprio quei territori che, nel tempo, hanno mostrato maggiore impegno e capacità gestionale.
Di fronte a questa situazione, il messaggio delle Regioni è chiaro: serve una governance ambientale più giusta, coerente e condivisa. Il rischio, altrimenti, è che si crei un cortocircuito istituzionale, dove le Regioni si trovano ad attuare piani imposti dall’alto, senza mezzi né autonomia vera. Il governo ha fissato tre anni come orizzonte temporale per l’attuazione delle misure anti-smog, ma se non verrà trovata una mediazione politica e istituzionale lo scontro rischia di paralizzare proprio quelle azioni che dovrebbero invece essere accelerate. Per questo i governatori auspicano una revisione del Piano e una reale condivisione degli obiettivi, delle modalità e soprattutto delle risorse. La battaglia legale è solo l’inizio: in gioco c’è il futuro della cooperazione tra livelli di governo e l’efficacia delle politiche ambientali in Italia.