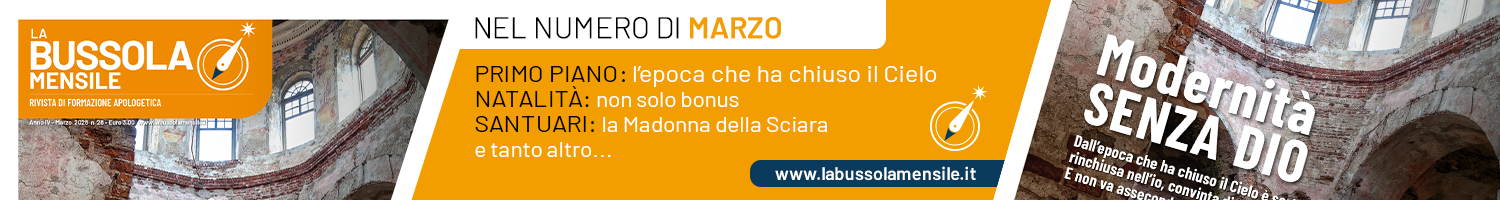L'eutanasia di un magistrato e la morte del "tu"
Il magistrato Pietro D'Amico, affetto da depressione, è andato a morire in una clinica svizzera lasciando tutti all'oscuro della decisione. E' il frutto della cultura dell'«obbligo di solitudine». In questo modo a morire è anche l'idea di relazione: suicidandosi si uccidono gli altri.

“La morte di un uomo è meno affar suo che di chi gli sopravvive”. Questo scriveva Thomas Mann ne La montagna incantata e questo si potrebbe scrivere come epitaffio per la scomparsa del 62enne magistrato Pietro D’Amico, il quale qualche giorno fa ha deciso di morire in una clinica di Basilea specializzata nel dare la “dolce morte”. D’Amico fu indagato dalla procura di Salerno nel 2007 per presunte fughe di notizie dalle aule giudiziarie del distretto di Catanzaro in merito all’inchiesta Poseidone. Ne uscì indenne nel 2011 con l’archiviazione: “insussistenza della notizia di reato”, scrissero i giudici. Ma non ne uscì indenne la sua serenità interiore, confermano colleghi e amici. «Questa magistratura non mi merita» aveva detto a molti e così decise di togliersi la toga per sempre, ormai sconfortato e deluso. La depressione, forse per questo motivo o forse per altri solo a lui noti, lo portò dunque a compiere un ultimo viaggio in Svizzera.
Come si dice per la morte: non tutte le morti sono uguali; così si deve dire anche per l’eutanasia: non tutte le eutanasie sono uguali. Chi ha deciso di porre fine alla propria esistenza (forse di mezzo c’era un tumore, ma non si sa bene) è un giudice. D’Amico, filosofo del diritto e cultore del diritto romano e della cultura ebraica, negli ultimi tempi si era più volte pronunciato a favore dell’eutanasia. Questa scelta compiuta da un addetto ai lavori avrà una caduta massmediatica probabilmente di un certo rilievo. Se la richiesta di farla finita viene da una persona con la terza elementare in tasca e ormai in fase terminale della sua malattia, le motivazioni per difendere la sua scelta potranno solo essere quelle emozionali o proprio di un certo peloso umanitarismo. Se invece, come nel caso di D’Amico, la decisione è assunta da un esperto di diritto ecco che l’eutanasia non è più solo affare che attiene al dolore fisico e psichico, ma è questione che attiene alle leggi. Qui c’è una persona che con nitore intellettuale sapeva quello che andava a compiere e non era mosso da suggestioni popolari, da malsani trend culturali. D’Amico non poteva essere stato vittima di un plagio ideologico, dunque. E allora la sua scelta – così diranno forse alcuni commentatori – era fondata su riflessione profonda e su motivazioni anche di carattere giuridico. La vicenda dell’ex magistrato offre quindi una sorta di imprimatur di carattere giuridico all’eutanasia. Purtroppo però il dolore, nato anche dal male di vivere, può offuscare persino le menti più fini e lucide.
Ma c’è un altro dato che fa riflettere. D’Amico non ha avvertito nessuno di quello che aveva in animo di compiere, né lo hanno fatto gli "assistenti". I familiari sono stati avvertiti dalla clinica svizzera ormai a cadavere freddo. Siamo forse ben oltre l’individualismo che costantemente caratterizza alcuni sfregi ai principi non negoziabili, che si imprime come un sigillo nella scelta della donna di abortire perché “il corpo è mio” negando la relazione con il figlio, nella fecondazione artificiale quando si avanza la pretesa tutta egocentrica di avere il figlio costi quel che costi, nel divorzio dove si impone l’ “io” rispetto al “tu”.
In questo caso pare quasi che ci sia l’obbligo di stare da soli e di fare tutto da soli. Una sorta di dovere morale di escludere gli altri e di negare la relazione: “extra omnes” quando si parla dell’ultimo respiro da emettere. Il morire diviene affare privatissimo e la scelta è davvero libera se svincolata da qualsiasi pressione esterna. E così a morire non è solo la persona che cerca l’eutanasia, ma la stessa idea di relazione: suicidandosi si uccidono gli altri. Gli affetti, i debiti di riconoscenza, le parole e i gesti che avrebbero potuto aiutare, sono soffocati in radice da un’asfittica scelta autoreferenziale, solipsistica ed inappellabile. Tanto inappellabile che non si sente il bisogno oppure addirittura si percepisce repulsa nel dire ai tuoi cari: “Voglio morire”. Ma nella realtà il gelido alito della Signora con la falce investe sempre e comunque chi è sopravvissuto al caro estinto ed era a lui vicino.
Accade anche nella contraccezione e nell’aborto delle minorenni: i genitori devono rimanere fuori perché intralcio ad una “libera” determinazione personale. In solitudine, e quando soprattutto la solitudine viene tutelata da certi orientamenti culturali, è meno angoscioso sopprimere il figlio che si porta in grembo, andarsene di casa ed anche chiudere gli occhi per sempre. Perché non ci sono mani che ti possono trattenere, mani che ti possono far riaccendere dentro una scintilla di speranza per cui valga la pena lottare.
Ma è dai tempi di Aristotele che sentiamo dire che la persona è animale sociale, cioè che l’uomo per natura è portato ad intessere relazioni e amicizie perché solo così riesce a vestirsi di umanità. E questo vale, come ci ammonisce Thomas Mann, anche per la morte. Con l’idea ormai frusta del “io sono mio” il contorno di parenti, amici, colleghi e conoscenti viene espropriato dell’altro e il mondo inizia e finisce laddove iniziano e finiscono il mio lavoro, i miei impegni, i miei interessi e le mie scelte, in un orizzonte esistenziale che ha la stretta curvatura dell’ “io”. Il “tu” è pronome defalcato dal vocabolario della vita in ossequio alla tanto celebre quanto amara strofa di Quasimodo: “Ognun sta solo sul cuor della terra”.