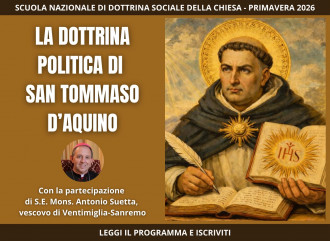Congo, raggiunto il cessate il fuoco. Il timore è che sia solo una pausa
Ascolta la versione audio dell'articolo
Il 19 luglio è stato raggiunto un accordo di cessate il fuoco fra gli M23 (gruppo guerrigliero sponsorizzato dal Rwanda) e la Repubblica Democratica del Congo, grazie alla mediazione statunitense. Se la pace regge, è una buona notizia per i cristiani.

Il 19 luglio, dopo settimane di negoziati, il governo della Repubblica Democratica del Congo (RDC) e il gruppo antigovernativo M23 hanno firmato a Doha, la capitale del Qatar, un accordo di cessate il fuoco. Si apre così uno spiraglio, se non di pace, di tregua per gli abitanti dell’est del paese stremati, vittime di una delle crisi umanitarie più gravi del pianeta: milioni di profughi, decine di migliaia di vittime civili. L’M23, formatosi nel 2012, è uno dei gruppi armati – ce ne sono decine – che da 30 anni combattono e imperversano pressoché incontrastati nelle province orientali del Nord e Sud Kivu e dell’Ituri confinanti con il Rwanda e l’Uganda, contendendosi il controllo di regioni ricche di risorse minerarie preziose: la loro fonte di finanziamento insieme alla sistematica razzia di raccolti e bestiame.
Gli M23 godono del sostegno finanziario e militare del Rwanda, divenuto più consistente a partire dal 2021 e, almeno da un anno, consolidato con l’invio di alcune migliaia di soldati rwandesi in territorio congolese. Sono anche la principale componente militare dell’Alleanza del fiume Congo, una coalizione antigovernativa di forze politiche e civili nata alla fine del 2023. È grazie all’aiuto militare rwandese che gli M23 negli ultimi tre anni sono riusciti a occupare territori sempre più estesi fino a controllare gran parte della provincia del Nord Kivu. Negli ultimi mesi del 2024 hanno marciato sulla capitale Goma, a fine gennaio l’hanno conquistata e poi si sono diretti verso sud e si sono impadroniti anche di Bukavu, la capitale della provincia del Sud Kivu.
Il Rwanda rifiuta l’accusa di Stato aggressore. Rivendica il diritto di appoggiare gli M23 per difendere i Banyamulenge, i Tutsi congolesi ai quali appartengono gran parte degli M23, dalle Forze democratiche per la liberazione del Rwanda (Fdlr), un gruppo di etnia Hutu, e impedire che le Fdlr penetrino in territorio rwandese. Tanto meno ammette di contrabbandare grandi quantità di minerali preziosi estratti nell’RDC, mentre sarebbe questo il secondo motivo che spinge il Rwanda a sostenere gli M23.
Per capire la complessità del contesto, occorre fare un passo indietro. 31 anni fa il Rwanda era governato dagli Hutu che, in un delirio razzista, nel 1994 decisero di sterminare tutti i Tutsi. Fu una strage senza precedenti. In 100 giorni furono uccise circa 940mila persone, per lo più Tutsi, ma anche Hutu: i pochi, contrari al genocidio. Quando il leader Tutsi Paul Kagame e i suoi soldati riuscirono a fermare il massacro e a prendere il potere nell’agosto del 1994, circa due milioni di Hutu si riversarono nell’RDC (all’epoca Zaire) e furono ospitati in un enorme complesso di campi profughi allestito dall’Onu. Con i civili però arrivarono anche i superstiti soldati dell’esercito Hutu e gli Hinterahamwe, la forza paramilitare Hutu che aveva svolto una ruolo determinante nel genocidio. Quello che ne resta e i loro discendenti militano adesso nelle Fdlr e, sostiene il governo rwandese non senza ragione, continuano a rappresentare una minaccia.
Gli M23 avevano già occupato Goma nel 2012, ma vi erano rimasti solo per qualche giorno. Il Rwanda aveva infatti accettato di smettere di sostenerli militarmente, cosa che aveva fatto per qualche tempo. Adesso la decisione dell’M23 di sottoscrivere il cessate il fuoco è legata all’accordo di pace firmato dal Rwanda e dall’RDC il 27 giugno scorso, con la mediazione degli Stati Uniti, riusciti nell’intento dopo una serie di tentativi falliti da parte di altri paesi, ultimo l’Angola. L’intesa sottoscritta a Washington dal ministro degli esteri congolese Thérèse Kayikwamba Wagner e da quello rwandese Olivier Nduhungirehe alla presenza del segretario di Stato Usa Marco Rubio impegna le parti al rispetto dell’integrità territoriale dei due paesi, e a rinunciare ad azioni ostili. Prevede il disarmo e l’integrazione dei gruppi armati non statali: oltre agli M23, anche gli altri gruppi antigovernativi minori e i wazalendo, una formazione paramilitare alleata dell’esercito governativo congolese. Inoltre include l’istituzione di un meccanismo di sicurezza congiunto.
Con il cessate il fuoco firmato il 19 luglio, il governo dell’RDC e l’M23 accettano di sospendere i combattimenti, la “propaganda di odio” e qualsiasi tentativo di conquistare con la forza nuove posizioni. I termini dell’intesa saranno definiti entro il 29 luglio in funzione di una fine delle ostilità che dovrebbe essere sancita in maniera definitiva da un accordo di pace fissato per il prossimo 18 agosto.
L’Unione Africana ha definito il cessate il fuoco una “pietra miliare” verso la pace e la sicurezza della regione. Ma il primo, enorme ostacolo è il ritiro degli M23 dai territori sotto il loro controllo. Il portavoce dell’RDC, Patrick Muyaya, ha affermato che l’accordo ha tenuto conto della “linea rossa” del governo, incluso il “ritiro non negoziabile” dell’M23 dalle aree occupate. Il portavoce dell’M23, Benjamin Mbonimpa, ha invece dichiarato che l’accordo non ha fatto menzione di un ritiro.
Il timore è che tutto possa ridursi a una mera pausa, senza che si affrontino e si rimuovano le cause all’origine del conflitto. Tra gli abitanti dell’est dell’RDC più in ansia per gli sviluppi delle prossime settimane ci sono i cristiani. Nei mesi in cui l’attenzione dell’esercito governativo e dei caschi blu della missione Onu di peacekeeping Monusco si è concentrata sul contrasto all’avanzata dell’M23, si sono intensificate le azioni contro le comunità cristiane di un altro gruppo armato, jihadista: l’Adf (Forze democratiche alleate), affiliato dal 2016 all’Isis, lo Stato islamico. L’attentato più grave risale allo scorso febbraio, quando un commando dopo aver attaccato diversi villaggi ha rinchiuso in una chiesa e ha ucciso 70 cristiani, donne e bambini inclusi.